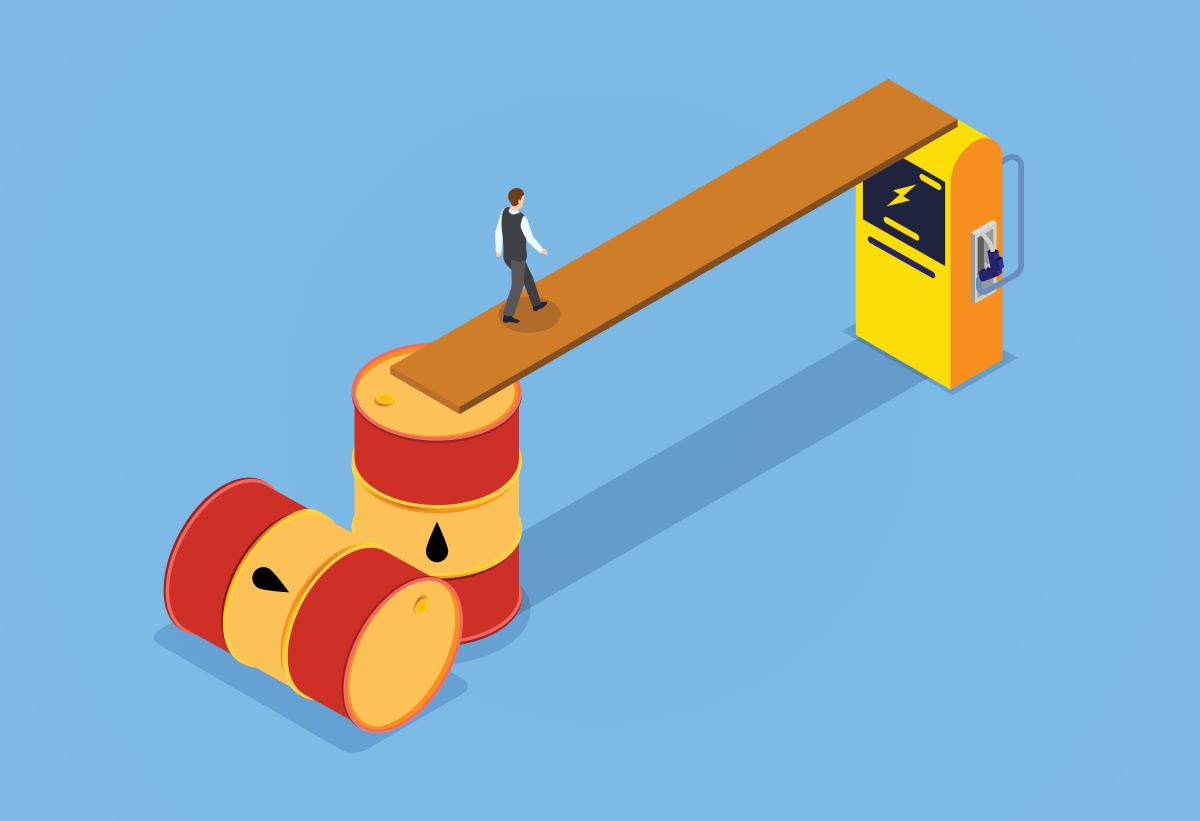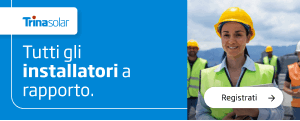Da quando è diventata la parola d’ordine di Ursula von der Leyen e, in Italia, del nuovo governo si discute molto di “Green New Deal”, non sempre a proposito.
Per esempio, in un convegno su questo tema le relazioni vertevano esclusivamente sugli obiettivi a lungo termine di riduzione dei consumi energetici e di crescita delle rinnovabili; è stato quindi interpretato come “New Green Deal” un nuovo accordo per realizzare questi due obiettivi.
Viceversa, la definizione “Green New Deal” è stata scelta dai democratici negli Stati Uniti, come esplicito richiamo al New Deal varato dal presidente Roosevelt per uscire dalla drammatica crisi innescata nel 1929 dal crollo del mercato azionario a Wall Street: un programma dotato di un volume senza precedenti di investimenti pubblici mirati alla crescita accelerata dell’economia e dell’occupazione.
L’aggiunta dell’aggettivo “green” comunica agli elettori americani che l’obiettivo è uno sviluppo economico non solo socialmente inclusivo, ma anche ambientalmente sostenibile.
Centrali, nella proposta dei democratici, sono:
- per tutti i cittadini retribuzioni adeguate, assenze per malattia e per ferie pagate, pensione di anzianità, assistenza sanitaria garantita, accesso all’istruzione (anche superiore), successivo addestramento e formazione per evitare la disoccupazione tecnologica, accesso a un’alimentazione sana a prezzi ragionevoli ad acqua e aria pulite;
- 100% della domanda elettrica soddisfatta con fonti a emissioni nulle, infrastrutture rinnovate con le migliori tecnologie disponibili in modo da eliminare l’inquinamento e le emissioni di gas serra, in particolare con investimenti nella mobilità elettrica pubblica e privata, efficientamento energetico degli edifici nuovi ed esistenti, rendendoli anche confortevoli e di lunga durata;
- trasformazione “green” della produzione agricola e industriale.
La proposta di un “Green New Deal” recupera la definizione di sviluppo ambientalmente sostenibile, contenuta nel Rapporto Bruntland del 1987, che considerava prioritari la centralità dei bisogni umani (quindi con una particolare attenzione alla povertà) e il concetto di limite – tecnologico, economico, ambientale – alla crescita della domanda e dell’offerta di determinati beni. Rapporto che costituì la base conoscitiva per la decisione dell’assemblea generale dell’Onu di organizzare nel 1992 a Rio la Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo.
Prima della proposta americana di un “Green New Deal”, l’integrazione degli obiettivi energetico-ambientali con quelli economici e sociali era stata recepita solo nel programma politico dei Verdi tedeschi. Altre forze politiche europee hanno appena incominciato a prenderla in considerazione, per ora esclusivamente a parole.
La “consapevolezza limitata”
Manca inoltre nel dibattito in corso sul “Green New Deal” una sufficiente attenzione al rischio che gli obiettivi proposti possano essere bloccati o eccessivamente ritardati dall’opposizione degli interessi economici e sociali minacciati dalle trasformazioni richieste, ma ancor più dall’indifferenza o dalla rassegnazione di una parte significativa dei cittadini, anche tra chi – fra loro – è consapevole della crisi climatica; comportamenti rafforzati dalla diffusa e crescente sfiducia nelle istituzioni e dal conseguente ripiegamento sugli interessi personali e dall’invecchiamento progressivo della popolazione nei paesi sviluppati.
Tendenzialmente le persone anziane sono più restie ad accettare innovazioni culturali e a cambiare abitudini, e meno interessate a problematiche di lungo periodo.
In Italia, secondo lo scenario mediano dell’Istat, nel 2045 la popolazione attiva scenderà al 54,3% del totale, con un’età media salita nel frattempo a 49,7 anni, mentre saranno sempre più minoranza i giovani, attualmente protagonisti delle più incisive manifestazioni contro i ritardi nella lotta al cambiamento climatico.
Tuttavia, secondo i risultati di un recente sondaggio della società di ricerca Astarea, il 32% degli italiani tra 18 e 34 anni è classificabile come “refrattario” (ha una visione estremamente parziale e quasi scorretta della sostenibilità), mentre i “coinvolti a 360 gradi” (comportamenti che dimostrano un impegno concreto sui temi della sostenibilità ambientale) sono il 25-26 %.
Pertanto, anche per le giovani generazioni si deve ancora parlare di “consapevolezza limitata” di quanto nella lotta al cambiamento climatico oltre all’impegno pubblico contino le proprie le proprie scelte di vita.
Ne deriva un circolo vizioso, che vede i governi timorosi di prendere provvedimenti non condivisi da molti elettori, rafforzando in costoro il convincimento che non sia poi così urgente intervenire per garantire uno sviluppo ambientalmente sostenibile.
Se in Italia incontra resistenze la decisione di ridurre il contenuto di zuccheri nelle bevande gassate, che riduce sia l’obesità infantile sia le emissioni di CO2, è molto lunga la strada da percorrere prima che trovi largo consenso una politica di decarbonizzazione incisiva, in grado quindi di trasformare in profondità l’attuale assetto economico e sociale.
E ancora più lo è il tragitto che ci separa da un convincimento diffuso che la sostenibilità dello sviluppo richieda anche cambiamenti rispetto agli attuali “stili di vita”, destinati a incidere sui comportamenti quotidiani: dalla dieta alimentare alla scelta dei mezzi di trasporto, dalla gestione oculata dei consumi alla selezione, negli acquisti, di prodotti ecocompatibili e di lunga durata.
Eppure, strumenti per sensibilizzare i cittadini su questi temi esistono da tempo, ma si tende a sottovalutarne l’importanza. Di conseguenza, sono praticamente assenti nel dibattito tra addetti ai lavori, nella comunicazione da loro rivolta ai cittadini, ma soprattutto non rientrano tra le richieste di cambiamento, per le quali il mondo ambientalista esercita pressioni sui decisori politici e sui vested interest.
Uno di questi strumenti è l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che nel 2015 ha definito 17 Sustainable Development Goals (Sdg), da realizzare entro il 2030 per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti.
Sono a loro volta articolati in 169 obiettivi globali e nazionali, che fanno riferimento a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico e istituzionale e sono monitorati da 244 indicatori misurabili.
L’Istat, a partire dal 2016, ha reso disponibili, con aggiornamenti semestrali, i Sdg per l’Italia. Nel 2015, sulla base delle conclusioni di un gruppo di lavoro, incaricato dalla Commissione europea di individuare indicatori dello sviluppo che incorporassero anche la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale.
Venne pubblicato il Rapporto Eurostat Measuring Gdp and Beyond, che proponeva strumenti specifici, successivamente recepiti dalla programmazione statistica annuale della Commissione (i programmi dell’Unione Europea, basandosi su altri indicatori, continuano però a ignorarli).
Anche in questo caso l’Istat ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il “Benessere equo e sostenibile” (Bes), con l’obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità.
Il Bes, continuamente aggiornato, viene determinato sulla base di dodici indicatori: salute, istruzione e formazione, conciliazione del lavoro e dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi.
Strumenti finiti in un cassetto
Sono ormai tanti i manifesti, le strutture organizzative create ad hoc, i position paper, con i quali i numeri uno di importanti gruppi industriali e finanziari manifestano la loro determinazione ad appoggiare politiche di contrasto al cambiamento climatico, anche attraverso l’impegno diretto all’interno delle proprie imprese.
Pur scontando una dose di effetto vetrina e la presenza di imprese che, di fronte al dilemma di Nanni Moretti, hanno deciso che è meglio esserci, sorprendono i dati contenuti in uno studio elaborato da Accenture Strategy e United Nations Global Compact (“The Decade to Deliver: A Call to Business Action”), presentato lo scorso settembre alle Nazioni Unite.
Sono stati intervistati più di 1.000 amministratori delegati delle principali imprese mondiali: solo il 21% degli interrogati ritiene fondamentale il contributo delle imprese per la realizzazione degli obiettivi globali e meno della metà di questi (48%) sta gestendo il proprio business in un’ottica di sostenibilità.
In Italia una sorte solo formalmente migliore è toccata al Bes (Benessere equo e sostenibile).
La legge n. 163/2016 di riforma del bilancio dello Stato ha previsto che Il Documento di Economia e Finanza (Def) debba includere un allegato, che per i dodici indicatori del Bes documenta l’andamento nell’ultimo triennio e come verranno modificati dal raggiungimento degli obiettivi del Def. Inoltre, a febbraio di ciascun anno va presentata al Parlamento una relazione che metta in evidenza gli effetti della legge di bilancio sui tali indicatori.
Queste disposizioni sono state puntualmente attuate, senza però che gli andamenti del Bes abbiano un impatto reale sulle decisioni del Governo e del Parlamento, ma – quel che più conta – la loro esistenza è conosciuta soltanto da un ristretto gruppo di addetti ai lavori e di uomini delle istituzioni, mentre ogni giorno informazioni e commenti relativi all’andamento del Pil continuano a essere presenti su tutta l’ormai diversificata gamma di media a nostra disposizione. Del Bes si parla invece raramente, spesso per affermare che come strumento decisionale è inadeguato.
All’inizio anche il Pil era pieno di pecche, soprattutto per le carenze e le imprecisioni dei dati statistici, ma, essendo uno strumento funzionale ad obiettivi che mirano esclusivamente alla crescita economica, è stato prontamente adottato, confidando nei perfezionamenti suggeriti dal suo utilizzo. Viceversa, il Bes non ha la stessa fortuna del Pil: continua dunque a prevalere lo sviluppo sostenibile inteso come crescita economica sostenibile, anche se la crisi finanziaria esplosa nel 2007 dovrebbe per lo meno introdurre qualche dubbio sulla sostenibilità di tale modello.
Ciò che manca
Quale posto nelle iniziative di contrasto al cambiamento climatico hanno finora trovato campagne per diffondere informazioni sull’esistenza e sui contenuti del Bes e dei Sdg?
Tra le tante proposte presentate negli ultimi anni dal mondo ambientalista a Governo e Parlamento, non se ne trova una che richieda per lo meno di associare l’andamento del Bes (nella fase iniziale spiegandone il significato) a quello del Pil in tutte le dichiarazioni e in tutti i documenti ufficiali.
Poiché la congiura del silenzio sul Bes da parte delle istituzioni rivela il timore per le possibili conseguenze che avrebbe la costante diffusione dei suoi dati tra cittadini resi consapevoli del loro significato, risulta ancora più sorprendente la disattenzione da parte di chi avrebbe interesse a discussioni sulle strategie di sviluppo valutate sulla base degli andamenti del Bes o dei Sdg.
Un’analoga campagna per introdurre un indicatore dello sviluppo equo e sostenibile dovrebbe coinvolgere l’insieme delle organizzazioni che negli Stati membri sono impegnate nel contrasto al cambiamento climatico, con l’obiettivo di arrivare a una Direttiva che ne imponga l’adozione; inizialmente accanto al Pil e che, una volta collaudato e perfezionato, lo sostituisca nell’orientare le scelte economiche. In parallelo le grandi aziende andrebbero sollecitate a correlare i propri business plan ai Sdg.
Senza questa discontinuità, in grado anche di dare un contributo fondamentale, se non decisivo, nel far crescere la consapevolezza dei cittadini sulla posta in gioco in campo climatico e ambientale, influenzandone i comportamenti, ci priveremmo della bussola necessaria per non deviare dalla giusta rotta nel processo di decarbonizzazione.
Che la tenacia nel perseguire questa linea paghi, lo conferma l’iniziativa dell’Associazione per lo sviluppo sostenibile (Asvis), la quale dal 2016 presenta un rapporto in cui viene fatto il punto sull’attuazione dei Sdg nazionali e si avanzano proposte puntuali sulle misure necessarie per realizzarli.
Nei primi tre anni la presentazione del rapporto aveva registrato presenze che, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, la collocavano fra le iniziative di questo genere con un’audience soddisfacente.
Quest’anno si è verificato un imprevisto e imprevedibile “overbooking”, che ha obbligato a disdire la sede inizialmente prevista, trasferendo la presentazione del rapporto in una sala molto più capiente. Ciò nonostante, si è realizzato il tutto esaurito, con l’inconsueta presenza di un autentico “parterre des rois”: Presidente della Repubblica e della Camera dei deputati, tre ministri (tra cui quello dell’economia), il segretario del Pd, in video il candidato commissario Ue italiano. Con un messaggio del premier Conte, che si rammaricava di non potervi partecipare. È solo un piccolo passo in avanti, ma significativo.
L’articolo è stato pubblicato sul n.5/2019 della rivista bimestrale QualEnergia con il titolo “Il New Deal diventa Green”.