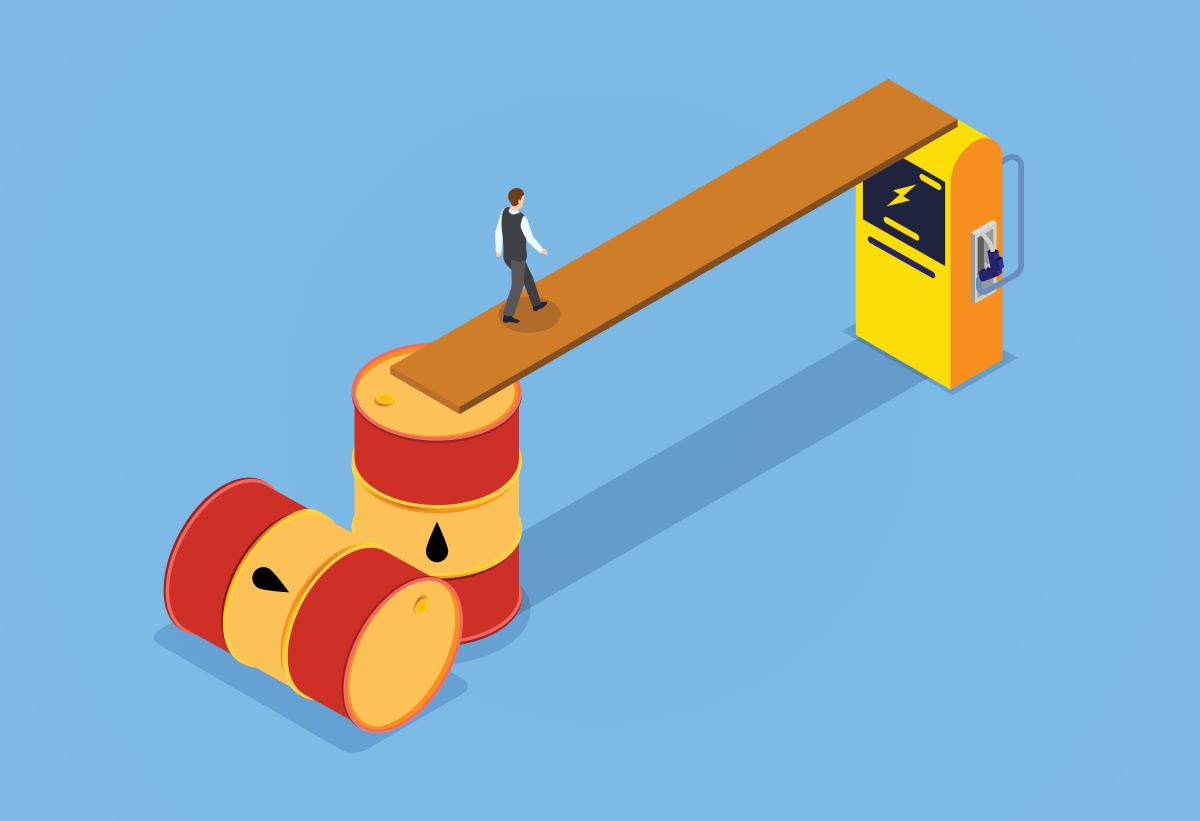Nel pomeriggio dell’11 marzo 2011, esattamente undici anni fa, un terremoto di intensità 9 scosse la costa orientale del Giappone.
Lo tsunami che ne seguì colpì una centrale nucleare con onde di quasi 14 metri e… non successe nulla.
Già, non stiamo parlando di Fukushima, ma della centrale di Onagawa, costruita sulla costa del Pacifico 90 km a nord di quella di Fukushima: anche se danneggiata dal terremoto, uscì del tutto indenne dallo tsunami, tanto che fu usata come rifugio per i profughi delle città intorno.
 È Onagawa, in un certo senso, la protagonista del nuovo saggio di Andrew Leatherbarrow, grafico 35enne, ma ormai di professione saggista esperto in catastrofi: dopo il suo Chernobyl, da cui è stata in parte tratta la serie Tv, arriva ora per Salani Editore il dettagliatissimo “Fukushima. Il sole si scioglie”, dove esamina le cause del secondo più grave incidente nucleare della storia, dopo aver consultato migliaia di documenti e intervistato decine di esperti sull’argomento.
È Onagawa, in un certo senso, la protagonista del nuovo saggio di Andrew Leatherbarrow, grafico 35enne, ma ormai di professione saggista esperto in catastrofi: dopo il suo Chernobyl, da cui è stata in parte tratta la serie Tv, arriva ora per Salani Editore il dettagliatissimo “Fukushima. Il sole si scioglie”, dove esamina le cause del secondo più grave incidente nucleare della storia, dopo aver consultato migliaia di documenti e intervistato decine di esperti sull’argomento.
“Il disastro di Fukushima viene spesso narrato come una fatalità: un incidente dovuto a una rarissima combinazione di due disastri naturali estremi, a cui nulla avrebbe potuto resistere. Ma Onagawa dimostra che non è così: quella centrale colpita dallo stesso tsunami restò indenne, dimostrando che dietro alla distruzione dell’altro impianto, in cui esplosero tre dei sei reattori, e dove solo per caso le cose non si sono messe talmente male da rendere inabitabile parte del Giappone, ci fu anche una grossa responsabilità umana”, ci dice Leatherbarrow.
A fare la differenza fu il fatto che Onagawa era proprietà della Tōhoku Electric, il cui vicepresidente, Yanosuke Hirai, era ossessionato dalla sicurezza, per cui pretese un muro di protezione sul mare di 13 metri di altezza, sapendo che l’area era colpita da rari, ma devastanti tsunami.
Fukushima era invece proprietà della Tepco, il cui management era molto meno sensibile all’argomento sicurezza: prima del 2011 la stessa centrale era già stata colpita da altri tre incidenti.
“Fukushima era protetta dal mare da un muro di soli cinque metri di altezza, buono per bloccare le onde alzate dai tifoni, non certo quelle di un grande tsunami. E quel muro restò tale anche dopo che nel 2006 un rapporto interno alla Tepco avvertì che le onde dei maremoti nell’area potevano superare i 10 metri e che in un caso del genere la centrale sarebbe stata distrutta. Ai dirigenti quella evenienza sembrava troppo remota, per spendere altri soldi a difesa di una centrale che già aveva quasi 50 anni di vita, e che sembrava molto improbabile fosse colpita da qualcosa del genere prima del suo smantellamento”.
E invece accadde, e il mare, irrompendo nei locali dei generatori diesel di emergenza della centrale, sistemati incoscientemente pochi metri sopra la costa, vennero distrutti.
Anche se Fukushima si era fermata automaticamente per il sisma, il calore provocato nel nocciolo dagli isotopi radioattivi creati dalla fissione nucleare, doveva essere dissipato con un continuo raffreddamento ad acqua. Ma l’elettricità esterna si era interrotta per i danni alle linee provocati dalle violente scosse, mentre a eliminare quella dei generatori diesel ci aveva pensato lo tsunami.
“Tutti i tentativi di raffreddare i reattori con pompe a motore, come quelle dei pompieri, fallirono, perché le strade erano impercorribili, e certe volte gli attacchi dei tubi non coincidevano. Così ben presto l’acqua nei reattori cominciò a bollire, scoprendo gli elementi del combustibile. Quando questi superarono i 2000 gradi di temperatura, i noccioli fusero, raccogliendosi nel fondo in cemento degli edifici di contenimento, mentre lo zirconio che rivestiva le pastiglie di uranio reagì con il vapore acqueo, formando idrogeno. Questo andò ad accumularsi negli edifici dei reattori, perché in assenza di elettricità, non si riuscirono ad aprire le valvole di ventilazione”.
Così, esplosero il reattore 1, poi il 3 e, infine, il 4, anche se quest’ultimo, senza combustibile, saltò in aria a causa del gas infiltratosi dal 3.
Sul reattore 4, però, c’era una piscina stracarica di barre di combustibile esaurito in fase di raffreddamento: si fosse rotta e asciugata, avrebbe esposto all’aria le barre, che avrebbero preso fuoco e contaminato tutto. Per fortuna del Giappone, la piscina resse.
“A questo punto gli ultimi, eroici, 49 operatori rimasti a Fukushima, aspettavano che esplodesse anche il reattore numero 2, uccidendoli o obbligandoli ad andarsene per le radiazioni. La centrale sarebbe stata allora abbandonata al suo destino di fusione incontrollata ed emissione di isotopi radioattivi nell’aria, condannando forse parte del Giappone a diventare inabitabile per decenni”, dice Leatherbarrow.
Invece il reattore 2, pur fondendo come gli altri, non esplose: per pura fortuna lo scoppio del reattore 1 aveva aperto un buco nel suo edificio, impedendo all’idrogeno di accumularsi.
“Così gli operatori, contravvenendo agli ordini della Tepco, che, incredibilmente, sperava ancora di salvare i reattori, ebbero tempo di pomparvi dentro acqua di mare, riportando la situazione sotto controllo. Da allora, però, bisogna immagazzinare ogni giorno in serbatoi decine di tonnellate d’acqua di raffreddamento e di falda, resa radioattiva dal passaggio attraverso i reattori fusi”.
Non bisogna però credere che il disastro di Fukushima sia dipeso solo dai manager della Tepco: fu il frutto di una disfunzione di sistema molto più vasta, in un paese come il Giappone che fra tifoni, vulcani, terremoti e tsunami, avrebbe dovuto essere il più attento al mondo nella sicurezza nucleare.
“Tutto il sistema che girava intorno all’energia nucleare in Giappone era marcio”, spiega l’autore del libro.
“Visto che si contava su questa fonte per rendere il paese energeticamente indipendente, tutto gli era concesso: era l’industria a scriversi le sue regole, le agenzie ‘indipendenti’ che dovevano controllarla le obbedivano, quasi tutti i giornali evitavano di criticarla e i politici erano da sommersi di prebende e bustarelle. Prima di Fukushima ci sono stati altri 18 incidenti nucleari in Giappone, alcuni mortali, causati dall’aggiramento di norme di sicurezza o impreparazione del personale, di cui si è parlato il meno possibile, impedendo che inducessero una sostanziale riforma del sistema”.
Nel libro si riportano episodi grotteschi, come quando l’Agenzia di Sicurezza Nucleare reclutò comparse perché si fingessero giornalisti e facessero le “domande giuste” per mettere sotto una buona luce il progetto dei reattori autofertilizzanti (poi rivelatisi un costosissimo fallimento).
Oggi in Giappone solo 10 dei 54 reattori in funzione prima di Fukushima sono ripartiti, ma visto che è previsto che il nucleare nel paese giochi ancora un ruolo importante in funzione della riduzione delle emissioni di CO2, si spera che la sicurezza in futuro sia presa più sul serio.
“Intanto restano i suoi tre reattori fusi su cui non si sa bene come intervenire. Un conto che fra danni, decontaminazione con milioni di tonnellate di terra radioattiva in sacchi di plastica sparsi per tutto il Giappone che attendono una sistemazione finale, e smantellamento potrebbe arrivare a 728 miliardi di dollari, mentre 1,4 milioni di tonnellate di acqua di raffreddamento contaminata da trizio verranno riversate in mare, facendo infuriare cinesi e coreani. La centrale di Fukushima a 11 anni dall’incidente, resta un monumento a una tecnologia energetica prodigiosa, ma forse anche troppo complessa e rischiosa per le imperfette menti e società umane”.
Ma, alla fine, è peggio per il nucleare il sistema sovietico che ha creato Chernobyl, o quello capitalista che ha creato Fukushima?
“Entrambi hanno fatto gravi errori, soprattutto per il desiderio di contenere i costi, ma quello sovietico era certo peggiore, per la segretezza, la mancanza di trasparenza e l’assoluta obbedienza a gerarchie e ideologia. Il nucleare ‘capitalista’, se non altro, si può correggere, sotto la spinta dell’opinione pubblica e di autorità indipendenti di controllo”, conclude Leatherbarrow.



.jpg)






















.gif)