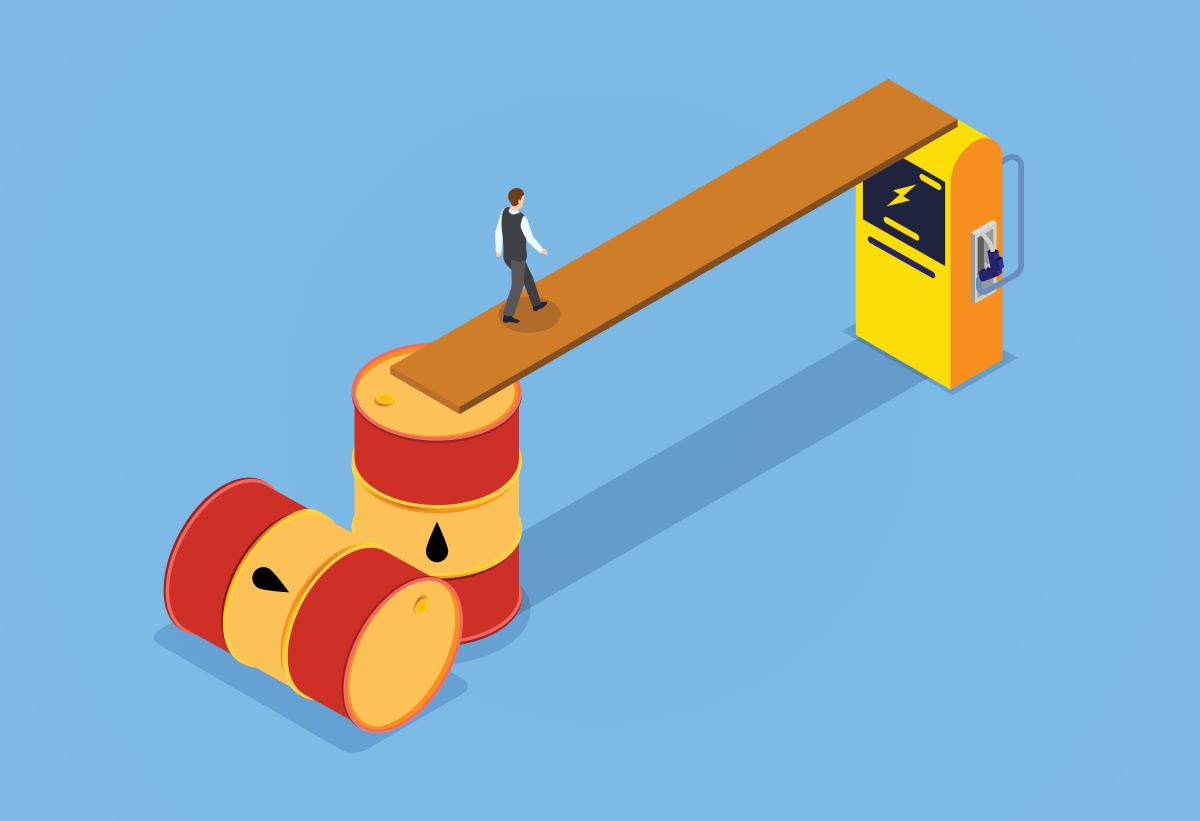Quanto pesa l’industria della moda sul cambiamento climatico?
Le diverse stime sulle emissioni globali di gas serra del settore moda variano dal 3 al 10%.
Stando ai dati più recenti, il report del 2020 di McKinsey, “Fashion on climate“, ci spiega che nel 2018 l’industria dell’abbigliamento è stata responsabile del 4% delle emissioni globali, circa 2,1 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti, in pratica quanto Francia, Regno Unito e Germania messi insieme. Il calcolo si basa sugli indumenti prodotti, utilizzati e smaltiti nel 2018.
Secondo questi dati l’industria della moda è sulla strada giusta per sforare ampiamente l’obiettivo di ridurre della metà le sue emissioni al 2030.
Senza ulteriori sforzi, tra 10 anni, questo comparto emetterà più o meno quanto oggi. Ma se la domanda di abbigliamento dovesse aumentare, come si prevede, le emissioni di carbonio salirebbero a circa 2,7 mld ton/anno anno entro il 2030, cioè +28%, in assenza di azioni concrete e ambiziose di abbattimento.
Un report di Quantis del 2018 ha calcolato che abbigliamento e calzature sono responsabili dell’8% delle emissioni globali. Lo studio considera la produzione del 2016 e presenta i risultati dell’impatto del settore su clima, acqua e salute umana.
Riguardo all’impatto sul clima, l’industria dell’abbigliamento sarebbe responsabile del 6,7% delle emissioni globali, circa 3,3 mld di tonnellate di CO2eq, mentre quello dell’industria calzaturiera per l’1,4%, pari a 700 milioni t di gas climalteranti. Per avere un’idea del totale, si tratta di quanto emette l’intera Unione Europea.
Perché la moda crea così tante emissioni?
Il problema principale è da ricercare nella lunga catena di approvvigionamento. La produzione è delocalizzata nei Paesi in cui il costo del lavoro è più basso, e dove spesso non è riconosciuto nemmeno un salario di sussistenza (per approfondire su Fattidistile.it: “Moda e salario dignitoso, i conti non tornano) e dove non ci sono regole e sono scarsi i controlli a tutela della salute di lavoratori e ambiente.
Le catene di approvvigionamento vanno dalla produzione della materia prima fino al prodotto finito. Il tutto si svolge tra appalti, subappalti e lavoro informale.
Insomma, per un’azienda avere il controllo dell’intera filiera non è cosa semplice. Ma non impossibile. Se l’azienda fosse consapevole della propria filiera di produzione, potrebbe intervenire su più fronti e impegnarsi a risolvere diverse questioni, come di vigilare e promuovere i diritti dei lavoratori delle fabbriche, oltre che incentivare e affiancare i propri fornitori ad adottare misure di efficienza energetica e il passaggio alle fonti rinnovabili.
Infatti, il grosso delle emissioni, circa il 90%, avviene proprio nelle catene di approvvigionamento, concentrate per lo più in Cina, Bangladesh, Vietnam, Turchia, India, Indonesia, Cambogia, paesi dove i combustibili fossili sono preponderanti nel mix energetico.
C’è anche da dire che il 70% delle emissioni proviene da attività di produzione a monte, come la produzione e la lavorazione della materia prima. In generale, tintura e finissaggio, preparazione del filato e produzione di fibre tendono a essere le fasi a più alta intensità di carbonio.
A proposito di tessuti, i marchi di moda, specie del fast fashion, hanno aumentato la domanda di fibre di origine fossile, come poliestere, nylon e acrilico. La produzione di queste fibre sintetiche causa dal 15 al 20% delle emissioni climatiche del settore della moda, scrive Stand.earth nel report “Fossil-Free Fashion Scorecard”. E oggi il poliestere rappresenta la metà di tutti i tessuti.
Cosa sta facendo l’industria della moda per ridurre il proprio impatto sul clima?
Molti dei più grandi marchi globali hanno siglato la Carta per l’Azione Climatica dell’Industria della Moda (Fashion Industry Charter for Climate Action) promossa dalle Nazioni Unite nel 2018.
L’impegno è anche quello di ridurre le emissioni climatiche del 30% entro il 2030, anche nelle catene di approvvigionamento.
Nell’agosto 2021, quasi tre anni dopo il lancio della Carta per l’Azione Climatica, Stand.earth ha pubblicato il “Fossil Free Fashion Scorecard”, un documento che ha messo a confronto 47 leader mondiali dell’abbigliamento, tra brand dell’alta moda, fast fashion e abbigliamento sportivo.
È emerso che, se alcuni marchi hanno intrapreso azioni per passare dai combustibili fossili alle rinnovabili nelle proprie operazioni (sedi o negozi), la maggior parte aveva fatto pochi o nessun progresso per eliminare il carbone e gli altri combustibili fossili dalla loro catena di approvvigionamento.
Una nuova analisi di Stand.earth di fine ottobre ha preso in esame nove delle principali aziende firmatarie della Carta per l’Azione Climatica per capire nei fatti come si stanno comportando nel ridurre le emissioni nella filiera secondo gli obiettivi del -55% al 2030.
Ebbene, secondo Stand.earth si prevede che nessuna delle società considerate – American Eagle Outfitters, Fast Retailing (UNIQLO), Gap, H&M, Inditex (Zara), il gruppo di alta moda Kering, Lululemon, Levi’s e Nike – riuscirà a ridurre le emissioni nella loro catena di approvvigionamento a meno che non vengano intraprese azioni concrete già da quest’anno, come eliminare gradualmente carbone e gas, puntando su efficienza energetica e rinnovabili in tutta le loro catene di approvvigionamento.
L’analisi, che si basa su dati del 2018, cioè due anni prima della pandemia, ha dimostrato che otto aziende, delle nove esaminate, nel 2019 hanno incrementato le proprie emissioni. Ad esempio, la società madre di UNIQLO, Fast Retailing, ha registrato una crescita del 35%. Anche Gap, Kering e Levi’s hanno avuto un aumento a due cifre, rispettivamente dell’11,9%, del 12,3% e del 13,1%.
Nemmeno la pandemia ha frenato l’aumento delle emissioni
Nonostante la pandemia le emissioni in alcuni casi sono aumentate perfino nel 2020. È il caso di Nike con un aumento del 23,4%. Anche l’inquinamento climatico di Lululemon è cresciuto del 12,7% nel 2020.
Perfino il gigante del fast fashion H&M, che si è impegnato a ridurre l’inquinamento climatico del 41% entro il decennio, durante il periodo del Covid ha registrato un leggero aumento delle emissioni della catena di approvvigionamento (+1,7%).
Comunque, scrive Stand.earth, ci sono segnali promettenti. Intanto, Kering si è impegnata a passare al 100% di energia rinnovabile entro il 2030. Anche Nike e Levi’s hanno mostrato alcuni progressi nel promuovere l’uso di fonti pulite negli impianti di produzione. Gap, Inditex, Lululemon e UNIQLO, però, devono ancora assumere impegni pubblici per eliminare gradualmente il carbone dalla loro catena di approvvigionamento.
Il ruolo dei consumatori
Tra il 2000 e il 2015, il numero dei capi di abbigliamento prodotti ogni anno è più che raddoppiato, arrivando a circa 100 miliardi di unità.
Allo stesso tempo, come dimostra il report “A New Textiles Economy: Redesigning fashion’s future” di Ellen MacArthur Foundation, il numero di volte in cui un capo viene indossato (“tasso di utilizzo”) è diminuito di quasi il 40%.
Il risultato è che ogni anno enormi volumi di vestiti, che potrebbero ancora essere indossati o riciclati, finiscono in discarica o negli inceneritori. In pratica ogni secondo l’equivalente di un camion della spazzatura carico di vestiti finisce in discarica o incenerito. Ben poco viene recuperato. Non solo, a livello globale solo l’1% degli abiti viene riciclato per farne di nuovi.
Lo studio di Quantis ha dimostrato che l’impatto del settore dell’abbigliamento sulla crisi climatica è aumentato del 35% tra il 2005 e il 2016, a causa dei cambiamenti nei materiali (fibre a base di combustibili fossili), nelle abitudini di consumo e nei luoghi di produzione.
Se prevarrà uno scenario business as usual, l’impatto dell’industria dell’abbigliamento aumenterà costantemente nei prossimi 15 anni.
La prima cosa da fare, la più semplice, a costo zero, è quella di ridurre i consumi. Uscire dal sistema fast fashion, quello della moda veloce che arriva a fare 52 collezioni all’anno, facendo sembrare vecchio o fuori moda quello che era in vetrina il giorno prima.
Acquistare meno abiti, cercare di puntare sulla qualità e far durare quello che si acquista. Ricominciare a scambiare, affittare, comprare abbigliamento usato (Conviene comprare abbigliamento usato? C’è un risparmio enorme), sono alcune semplici azioni che consentono ai capi di rimanere in circolazione più a lungo, in un’ottica di economia circolare.
Solo con queste semplici azioni, secondo Mckinsey, si taglierebbero 143 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra al 2030.
Photo credit: Victoria Emerson from Pexels


























.gif)