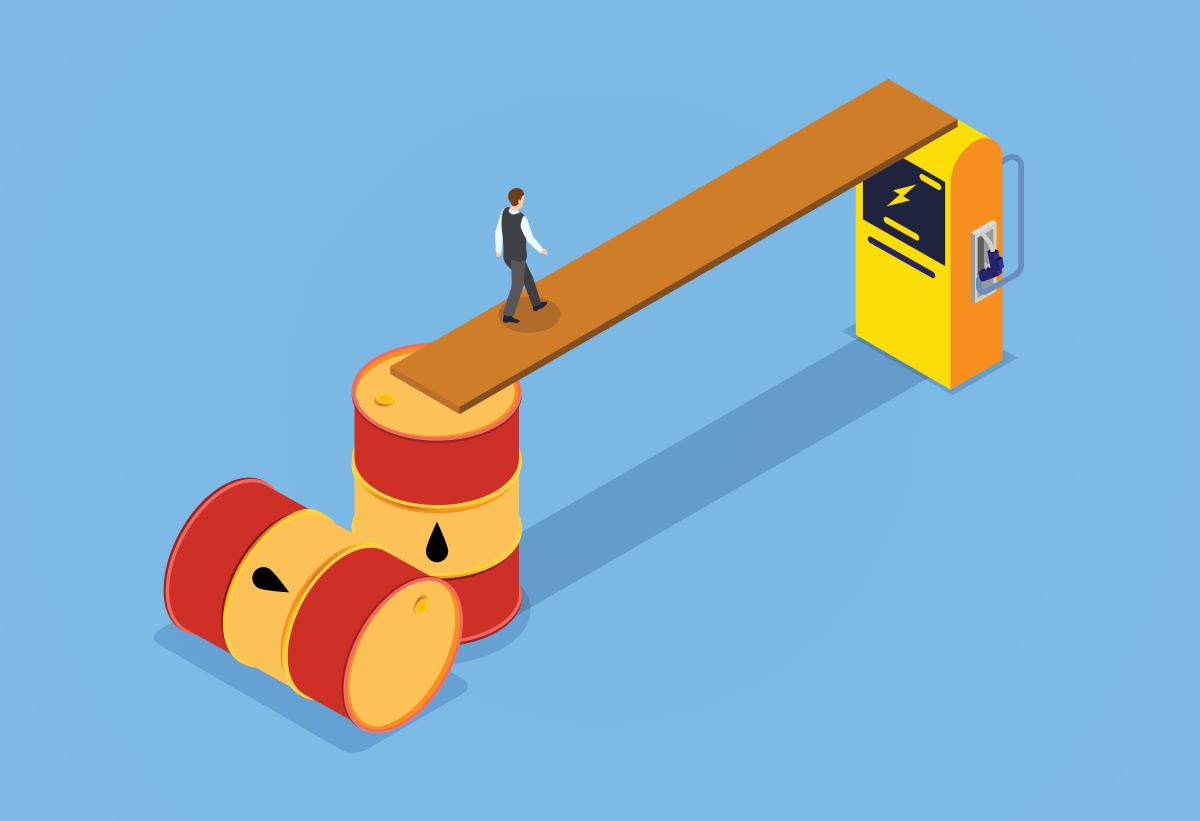Da parecchi anni nel nostro peregrinare per conferenze universitarie, da Padova a Palermo passando per RomaTre, abbiamo sottolineato agli studenti come la rivoluzione energetica per far fronte al global warming abbia, tra l’altro, il prezzo spesso sottaciuto della richiesta di metalli.
Più in generale di minerali, per il proliferare dei dispositivi elettronici e informatici, per la forte “elettrificazione” dei consumi energetici nei vari settori di impiego (trasporti, industria, usi domestici) e per l’enorme sviluppo globale della potenza da fonti rinnovabili.
Insomma, la transizione che da decenni tende a sostituire Sole, vento, smart grid e bit a sferraglianti processi industriali e ai camini fumiganti delle combustioni celebrerà il trionfo dell’occhio lungo del rapporto Saint-Geours alla Cee (1979) – la “dematerializzazione delle produzioni” e il disaccoppiamento tra energia e Pil – ma dovrà inevitabilmente pagare dei prezzi.
Minori di quelli che hanno portato all’attuale drammatico livello della crisi ambientale ma certo da non sottovalutare; perché, anche se ci liberano dall’era dei fossili, pannelli fotovoltaici e turbine eoliche hanno una loro corposa materialità.
Tutta la tecnologia green ha bisogno di risorse non rinnovabili, provenienti in larghissima misura da attività estrattive e, assai poco, da riutilizzo o riciclaggio. Già, l’altro corno della crisi ambientale: il consumo delle risorse naturali.
Il consumo di risorse naturali
A richiamare l’attenzione erano stati i dati di “Opening Pandora’s box” (Gaia Foundation, 2012), che illustravano l’impressionante incremento nel mondo dell’estrazione di ferro, nichel e cobalto nei dieci anni precedenti.
Un saccheggio delle risorse del sottosuolo cui faceva eco, sul suolo, la spoliazione operata dal land grabbing, cioè l’accaparramento di territori e acque dolci attraverso la compravendita operata da società multinazionali o da Stati nazionali di gigantesche aree di altri Paesi – una per tutte i circa 64 mila kmq per 162 compravendite concluse al 2020 in Brasile.
Il picco del land grabbing nel quinquennio 2005-2009 aveva portato l’International Land Coalition a denunciare, durante la Conferenza di Tirana (2011), una forma di neocolonialismo: «[…] acquisizioni di terre in violazione dei diritti umani, in assenza del consenso di chi le usava in precedenza e con nessuna considerazione degli impatti sociali e ambientali».
Il fenomeno non si è arrestato, con la conseguente deforestazione e perdita di diversità biologica; la dinamica del land grabbing, può essere monitorata rispetto allo stato attuale delle transazioni e degli investitori.
Sempre nel 2011, il rapporto Unep quantificava l’entità della spoliazione delle risorse naturali “chiave” – minerali, filoni metalliferi, combustibili fossili, biomasse – in quasi 50 miliardi di ton/anno, nel permanere di enormi disuguaglianze.
Ad esempio, a fronte delle 40 t/anno procapite di alcuni Paesi ricchi, le 4 t/anno in India; ma il consumo complessivo della sola India era di poco inferiore a quello mondiale all’inizio del XX secolo. Continuando così «nel 2050 gli esseri umani si potrebbero divorare 140 miliardi di tonnellate» delle quattro risorse chiave «molto di là di quanto sia verosimilmente sostenibile».
Per questo il rapporto Unep raccomandava, soprattutto ai Paesi ricchi, politiche di “disaccoppiamento” tra crescita economica e consumo di risorse: «disaccoppiamento non vuol dire uno stop alla crescita, ma fare di più con meno».
A che punto siamo oggi? Le cose non sono andate molto meglio, se il rapporto Unep 2019 registra un’incessante crescita della domanda dal 1970 al 2017: il 2,7% in media all’anno per i materiali metalliferi; da 9 a 44 miliardi di tonnellate, l’estrazione di minerali non metallici con sabbia, ghiaia e argilla ai primi posti; da 9 a 24 miliardi di tonnellate di biomasse, in larga misura raccolti e pasture; i combustibili fossili pur passando da 6 a 15 miliardi di tonnellate hanno rappresentato una quota calante dell’“estrazione” globale, dal 23 al 16%.
La stima UN dei quattro tipi di materiali chiave “estratti” dalla Terra nel 2017 era di 88,6 miliardi di tonnellate, secondo la progressione da 26,7 nel 1970 a 75,6 nel 2010. E il 22 gennaio 2020 The Guardian annunciava che si erano superati i 100 miliardi di tonnellate, citando i dati del rapporto che Circle Economy aveva presentato a Davos: 50,8 minerali; 10,1 metalli; 15,1 combustibili fossili e 24,6 biomasse.
Infine, il prelievo di acqua, cresciuto più velocemente dell’incremento della popolazione, è passato da 2.500 km3/anno (1970) a 3.900 km3/anno (2010) (70% in agricoltura, soprattutto irrigazione; 19% nell’industria e 11% per le città).
Poiché abbiamo accesso a soli 200.000 km3 d’acqua dolce – il 70% delle acque dolci è costituito dai ghiacci perenni – e la domanda supererà presto l’offerta, la Fao prevede nel 2025 un miliardo e ottocento milioni di persone in aree con assoluta scarsità d’acqua.
Le “terre rare” (Rare Earth Elements, Ree)
Le terre rare sono dei metalli, un gruppo di 17 elementi, quindici ‘Lantanidi’ – dal numero atomico 57 (Lantanio) al 71 (Lutezio) della tabella periodica di Mendeleev – più Ittrio (39) e Scandio (21).
Loro e le loro leghe hanno molteplici usi per oggetti ormai diffusi e familiari, a partire dai telefoni cellulari – relativamente pochi vent’anni fa, oggi più di 5 miliardi – proseguendo con memoria dei computer, Dvd, batterie ricaricabili, convertitori catalitici.
E poi, i magneti di alta potenza o capaci di sostenere temperature elevate, la generazione di immagini a risonanza magnetica per la diagnostica medica (Mri), la sicurezza valutaria e molti altri impieghi.
Il grafico che siamo soliti proporre agli studenti, da aggiornare periodicamente, mostra la storia dei Ree: gli Stati Uniti entrano nel mercato a metà degli anni ’60 con l’esplodere della domanda di televisori; i bassi prezzi praticati dalla Cina negli anni ’80-’90 fanno chiudere l’attività estrattiva in Usa; il taglio delle esportazioni cinesi (2010) fa schizzare i prezzi e motiva una nuova produzione negli Usa, in Australia, Russia e ‘altri’; dal 2018 i dati del Myanmar, in precedenza non disponibili, fanno esplodere la voce ‘altri’.
La produzione dei Ree è concentrata in pochi Paesi, come quasi tutte le materie prime critiche (CRMs), cruciali per la trasformazione verso una mobilità “low carbon”.
In particolare, i Ree sono diventati un caso di studio per come le strategie dell’industria automobilistica europea intendano far fronte ai rischi per l’approvvigionamento, in rapporto alla nuova domanda di CRMs dovuta allo spostamento verso la mobilità elettrica.
Scarsa consapevolezza, mancanza di buona volontà o di capacità progettuale per accedere alla produzione e assicurare i rifornimenti sono il poco confortante risultato dello studio (Schmid, M., 2020, Mineralogical Magazine, 84, 1, Cambridge University Press).
Eppure, i problemi richiedono grandi interventi proprio dell’industria, come sottolinea una lettera di ricercatori inglesi che, nella prospettiva “net zero” al 2050, quantificano in 207.900 tonnellate di cobalto, 264.000 di carbonato di litio, 7.200 di neodimio (Ree) e disprosio (Ree), 2.362.000 di rame i quantitativi per passare dagli attuali 31,5 milioni di motori a combustione interna (Icev) circolanti nell’UK ad altrettanti veicoli elettrici a batteria (Bev).
Circolare, ma per davvero
La storia delle risorse naturali racconta dell’ineguale distribuzione dei benefici del loro uso e del crescente e forte impatto sul well-being degli umani e sulla salute dell’ecosistema.
Mentre l’estrazione e il consumo crescono nei Paesi a reddito medio-alto, in quelli col reddito più elevato continua l’esternalizzazione delle produzioni a maggior intensità; per contro, una persona che vive nelle regioni ad alto reddito consuma in media il 60% in più di quella che vive in aree medio-alte e tredici volte di più di chi vive nei Paesi a basso reddito.
Complessivamente, l’estrazione e la lavorazione delle risorse naturali rappresentano oltre il 90% della perdita di biodiversità globale e degli impatti dello stress idrico e circa la metà delle emissioni globali di gas serra.
E il riciclaggio delle quattro risorse chiave ha camminato come il gambero: nel 2020 è sceso nel mondo all’8,6%, con una perdita dell’1% rispetto a due anni prima, mentre il loro consumo aumentava dell’8%. Il panorama delle potenzialità è meno sconsolante dei dati perché, per esempio, gran parte dei metalli necessari nel cammino verso la neutralità climatica al 2050 ha ancora riserve operative.
Si affaccia anche l’ipotesi dell’estrazione mineraria dai bacini oceanici, che però evidenzia al massimo il problema dell’impatto ecologico, della perdita della diversità biologica, mentre il tema delle estrazioni dal suolo ripropone le questioni della controllabilità della catena di approvvigionamento e dell’impatto sociale, fino al lavoro minorile.
Che fare di fronte a questo quadro?
Mentre al disaccoppiamento CO2/materie prime sta dando un significativo contributo l’affermarsi sempre più esteso delle energie rinnovabili al posto dei fossili, spetta ai Paesi avanzati attuare al massimo la raccomandazione del disaccoppiamento tra well-being e consumo delle risorse naturali, in modo che una quota, solo una quota, delle risorse così risparmiate possa mitigare lo sbilanciamento, a danno dei Paesi in via di sviluppo, nell’utilizzo pro capite; ma in un quadro di incessante riduzione dei miliardi di tonnellate impiegate ogni anno in tutto il mondo nel processo produttivo.
Ai Paesi avanzati spetta il compito di una colossale realizzazione di economia circolare: garantire al massimo riuso e riciclabilità dei prodotti, in particolare dei metalli necessari alle tecnologie “pulite”, per meglio fronteggiare i due principali corni della crisi ambientale: global warming e distruttiva spoliazione del pianeta.
Sono impegni che richiedono il protagonismo dei cittadini, una grande attenzione alla ricerca, il massimo sforzo dell’industria e delle imprese, una governance ambientale e sociale a livello globale.
Su tutto questo vanno giudicati i Pnrr dei Paesi della UE. E sui tempi della loro attuazione, ricordando la raccomandazione di Next Generation EU che il 40% degli obiettivi al 2030 sia realizzato entro il 2025.
L’articolo è tratto dalla rivista bimestrale QualEnergia (n.3/2021). Titolo originale: “I due corni del dilemma ambientale”.



.jpg)