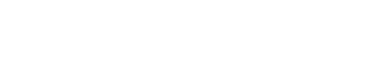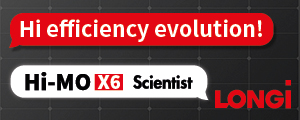In apparenza va tutto (o quasi) bene verso la transizione ad un modello energetico basato sulle energie rinnovabili.
Le installazione di solare FV continuano a superare le previsioni, sempre più paesi nel mondo parlano di bandire le auto con motore a scoppio, le multinazionali investono sempre di più nelle energie sostenibili, con l’ingresso del Nicaragua nell’Accordo di Parigi ormai tutto il mondo è compatto nella lotta al cambiamento climatico (anche gli Usa dovranno rimanervi almeno fino al 2020) e perfino Trump, forse per la sfilza di uragani che colpiscono il territorio americano, mostra qualche ripensamento.
Ma Frank Geels, professore di Innovazione dei Sistemi all’Università di Manchester, getta un secchio di acqua gelata sull’ottimismo generato da queste notizie.
Nello studio “Sociotechnical transitions for deep decarbonization”, apparso su Science, Geels e colleghi fanno rilevare che per raggiungere una chance ragionevole, valutata nel 66%, che si riescano veramente a mantenere le temperature sotto i 2 °C di aumento rispetto al 1850, occorrerebbe che le emissioni di CO2 raggiungessero un picco già nel 2020, arrivando a calare di almeno il 70% entro il 2055.
Per arrivare a un simile risultato in così pochi decenni, bisognerebbe, secondo IEA e IRENA (rispettivamente agenzia OCSE per l’energia ed Agenzia Onu per le rinnovabili), che l’attuale tasso di decarbonizzazione dell’economia triplicasse in ampiezza e velocità, puntando a migliorare l’efficienza energetica di tutti gli edifici del mondo, alla generazione del 95% dell’elettricità con rinnovabili e ottenere il passaggio di tutti i veicoli del mondo alla trazione elettrica, all’idrogeno/metano da rinnovabili o a biocombustibili.
Pertanto, quello a cui assistiamo adesso, e che ci pare così esaltante, è in realtà come tentare di vincere i 100 metri alle Olimpiadi facendo gareggiare un novantenne.
E quanto sia concretamente fattibile riuscire ad ottenere questo obbiettivo continuando con le politiche attuali, lo rivela del resto la stessa IEA quando pubblica le sue previsioni sui consumi energetici al 2040, vedendoli ancora largamente dominati da metano, petrolio e carbone, con le fonti rinnovabili che andranno a fornire appena un sesto dell’energia di quei tre.
Insomma la IEA indica la strada, ma non ci crede nemmeno lei che la percorreremo.
«Serve una ‘decarbonizzazione profonda’ – sintetizza Geels – ma nonostante i rapidi aumenti nelle installazione di energie rinnovabili, il tasso di progresso verso questo obbiettivo è ancora troppo lento».
Uno degli ostacoli che impediscono l’accelerazione è che ogni settore propone soluzioni tecniche o politiche separate, senza considerare il quadro sociale, economico, culturale e politico complessivo in cui queste soluzioni dovrebbero intervenire, spiega l’autore dello studio.
Per questo viene indicata una cornice “socio-tecnica”, in cui inserire tutti i diversi soggetti e le proposte, in modo che si armonizzino e si rinforzino a vicenda, accelerando la transizione.
Per far questo, Geels e colleghi hanno individuato tre punti chiave:
- Indebolire i sistemi socio-tecnologici esistenti
I sistemi socio-tecnologici del passato (cioè come le società si organizzano intorno a certe innovazioni tecnologiche, basti pensare al trasporto con motore a scoppio) hanno richiesto decenni per strutturarsi.
L’allineamento e l’interconnessione di queste tecnologie con mercato, infrastrutture, regolamenti e cultura, agiscono ora come una potente forma di resistenza contro il cambiamento. Se vogliamo accelerare la transizione, non basta gettare sul mercato nuove tecnologie, ma occorre anche indebolire i potenti blocchi socio-tecnologici precedenti.
Qualcosa è stato fatto: per esempio imporre limiti alle emissione delle centrali elettriche, mettere fuori commercio le lampadine a incandescenza o vietare in futuro le auto convenzionali nelle città, sono provvedimenti che vanno in questa direzione, erodendo le basi su cui poggiano i sistemi socio-tecnologici non sostenibili.
Ma per accelerare occorrerà fare molto di più e molto prima nella direzione del “minare l’ordine esistente”.
- Far convergere più tecnologie
I sistemi socio-tecnologici si affermano grazie alla convergenza di più innovazioni: per esempio l’estrazione del metano con il fracking è arrivato dalla convergenza di varie tecniche di prospezione, di trivellazione e di estrazione elaborate negli anni precedenti dall’industria petrolifera convenzionale.
Sarebbe ingenuo pensare che una singola innovazione nel campo delle energie rinnovabili possa da sola innescare una rivoluzione: senza la spinta ad applicare altre innovazioni, dall’aumento dell’efficienza energetica al controllo della domanda tramite la domotica, dagli algoritmi per la condivisione dell’energia autoprodotta fino ai sistemi di accumulo, la rivoluzione inciampa sui limiti tecnologici dell’innovazione principale e si ferma.
Per applicare questa convergenza di tecnologie è utile individuare delle nicchie di mercato. Per esempio certi quartieri cittadini, paesi o isole, in cui sperimentare i sistemi, perfezionarli e poi riportarli nel mercato generale, pronti e collaudati per funzionare.
- Offrire sostegno sociale, politico e di mercato
Nessun cambiamento socio-tecnologico può avvenire nei brevissimi tempi richiesti se non è supportato da un adeguato sostegno politico, sociale e di mercato.
Passare a un’economia decarbonizzata richiede enormi cambiamenti nel modo di muoversi, scaldarsi, nutrirsi e abitare di centinaia di milioni di persone. Queste vanno motivate a farlo certo con incentivi economici, per esempio tassando di più le vecchie tecnologie o detassando le nuove, ma servono anche incentivi sociali e culturali, cioè tanta informazione e tanta educazione, che spieghino l’importanza del cambiamento, ne illustrino i vantaggi anche a livello individuale, lo rendano socialmente “cool”, mettendo così “fuori moda” la vecchia maniera di vivere, e aumentino le pressioni sulla politica per proseguire lungo quella strada.
Al tempo stesso è indispensabile che anche il sistema industriale e finanziario spinga verso il cambiamento, ed è quindi necessario che abbiano l’impressione che la politica marci decisa in quella direzione, senza ripensamenti. Quindi, investimenti in direzioni divergenti non debbano essere redditizi.
Ciò porterà anche a creare una potente alleanza di industria e finanza “verdi”, che a loro volta premeranno sulla politica e sulla società perché affrettino la transizione, ponendo limiti sempre più severi alle vecchie tecnologie, in un circolo virtuoso, che accelererà sempre più il cambiamento.
Insomma, il vecchio modo con cui si guardava alla transizione verso la decarbonizzazione, era essenzialmente economico: cioè basato sulla valutazione dei costi delle varie tecnologie, per prevederne la diffusione.
Ma, secondo gli autori dello studio apparso su Science, questo aspetto, pur necessario, è tutt’altro che sufficiente: bisogna prendere in considerazione anche come le nuove tecnologie si impongono nel mondo reale, e quindi gli aspetti politici, di accettazione sociale e di approccio culturale connessi all’adozione di queste innovazioni (pensiamo, per esempio, all’enorme produzione culturale nata intorno all’auto).
«Se vogliamo compiere questa transizione nel mondo reale, nel pochissimo tempo che abbiamo per riuscirci – conclude Geels – i politici non dovrebbero stimolare lo sviluppo solo puntando sull’aspetto tecnico ed economico, ma costruire un consenso politico intorno ad esso, coinvolgendo il mondo produttivo, del lavoro e la società civile in questo processo. Così innescherebbero un circuito virtuoso di pressioni e incoraggiamento reciproci, che finiranno per accelerare esponenzialmente la transizione».



























.gif)