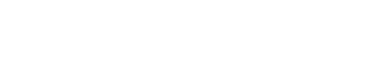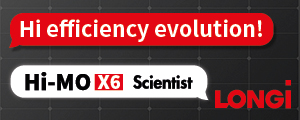“Contrordine, fa più freddo”, “Dov’è finito il riscaldamento globale?”, “Se il riscaldamento è globale… perché nevica?”
I titoli sulla questione climatica a volte sorprendono. Sembra che a ogni inverno rigido dovremmo mettere in discussione l’esistenza del problema del surriscaldamento globale. Quando nevica, poi, secondo alcuni non si dovrebbe più discutere dei cambiamenti climatici e dovremmo metterci tutti a costruire pupazzi di neve con la faccia di Al Gore. Insomma, mentre procedono lentamente e faticosamente i negoziati per definire un accordo mondiale onnicomprensivo sui cambiamenti climatici per il periodo successivo al 2012, il dibattito continua a essere animato. Ancora nel 2010, quando si discute di cambiamenti climatici, non deve mancare lo spazio per la voce dissenziente, per il convinto che si tratta di un problema inventato o esagerato. I quotidiani e i talk show televisivi sono affezionati a questa sorta di par condicio, e il messaggio che arriva al lettore è che «la scienza è divisa». Eppure, se si valuta la letteratura scientifica degli ultimi dieci anni, una produzione vastissima, si vede che le cose non stanno così: il dibattito sulle responsabilità umane in merito ai recenti e futuri cambiamenti climatici è ormai anacronistico. Dai risultati ottenuti dai più grandi centri di ricerca, dagli editoriali delle più prestigiose riviste internazionali, dai rapporti delle Accademie delle Scienze o di altre istituzioni scientifiche super partes, emerge che si è passati oltre.
Il cuore del dibattito è ormai altrove, per esempio quanto potrà in futuro riscaldarsi il Pianeta, in relazione alle emissioni umane di gas serra; quali potrebbero essere i feedback positivi su lunghe scale temporali in grado di amplificare questo riscaldamento; nonché l’esistenza di possibili tipping points, soglie critiche che – se superate – potrebbero far variare bruscamente alcuni parametri climatici o impedire il ritorno alle condizioni precedenti.
La comunità scientifica sta sfornando a ripetizione lavori di grandissimo spessore che tolgono molti dei dubbi del passato. Ormai gli studiosi del clima discutono sui dettagli, e forniscono un quadro sempre più preoccupante. Le recenti sintesi della Copenhagen Diagnosis e della Royal Society inglese confermano il quadro delle conoscenze emerso dal quarto rapporto dell’IPCC del 2007. Si è riconosciuto, come già successo in altri settori, un consenso scientifico sulla realtà del riscaldamento in atto, sulla determinante influenza umana e sulla pericolosità dei danni attesi nei prossimi decenni.
Mentre si perde ancora molto tempo a discutere tesi che di fatto non esistono nel dibattito scientifico, negli ultimi anni la scienza del clima ha portato elementi che inducono a una maggiore preoccupazione per gli impatti dei cambiamenti climatici, e alcuni di questi sono legati a sistemi di feedback, di retroazione, che erano conosciuti a livello teorico ma i cui effetti si possono ora misurare. Per esempio il riscaldamento della zona artica e il ghiaccio marino artico hanno avuto un andamento che ha più che confermato le proiezioni degli studiosi del clima.
Mike Serreze, uno dei maggiori studiosi della materia, ha scritto che il ghiaccio marino artico ha imboccato una «spirale mortale». Stessa cosa per i dati che mostrano ratei crescenti di deglaciazione della calotta glaciale della Groenlandia e della penisola Ovest Antartica. Non c’è alcun problema a riconoscere che, occupandosi di una cosa così complessa come il clima del Pianeta, rimangano zone d’ombra, punti da spiegare meglio (per esempio il ruolo dei diversi tipi di aerosol e nubi, l’inerzia termica degli oceani, ecc.). I risultati hanno margini di errore e l’affidabilità delle proiezione climatiche va migliorata. È comunque sempre utile cercare spiegazioni alternative e approfondire l’influenza di tutti i fattori che influenzano il clima della Terra. Questi ulteriori approfondimenti però non devono essere la scusa per ritardare le azioni necessarie, che già sono urgenti. Invece, la mancanza della certezza assoluta e l’esistenza di voci dissenzienti sono spesso usate proprio per chiedere cautela nelle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici.
Il punto è che se si applica alle tesi che sostengono spiegazioni alternative al riscaldamento globale lo stesso atteggiamento scettico, rigoroso dal punto di vista scientifico, con cui si valuta la spiegazione prevalente del riscaldamento globale, tutte le teorie che hanno proposto spiegazioni alternative non reggono. Pur se a volte hanno un largo successo su internet e assicurano un po’ di notorietà ai loro autori, vengono inesorabilmente, verrebbe da dire spietatamente, stroncate nel giro di qualche mese o anno.
La bibliografia è ampia ed è stata sintetizzata nel mio libro “A qualcuno piace caldo” (e in forma più sintetica e divulgativa nel recente “Guida alle leggende sul clima che cambia“) ed è periodicamente aggiornata in diversi blog scientifici, fra cui Climalteranti.it e in lingua inglese Realclimate.org e Skepticalscience.com. In particolare, le principali teorie che negli ultimi anni hanno proposto spiegazioni alternative hanno ipotizzato una maggiore responsabilità del Sole nelle variazioni climatiche, tramite meccanismi sempre nuovi (macchie solari, raggi cosmici, variazione del campo magnetico o gravitazionale o della rotazione terrestre). A volte i meccanismi non sono neppure conosciuti, ma solo ipotizzati in modo semplicistico, e ci si affida a modelli statistici che rinunciano allo sforzo di interpretare “fisicamente” e matematicamente i processi climatici, ma si basano su analisi statistiche che cercano di attribuire una rilevante parte del recente riscaldamento globale a cicli naturali. Il dibattito scientifico ne ha evidenziato molti punti deboli: metodologie e selezione dei dati discutibili, scarsa trasparenza, a volte palesi falsificazioni. Le motivazioni di chi nega l’origine antropica del riscaldamento globale sono fra le più diverse.
In Italia queste posizioni non sembrano avere come prima e diretta spiegazione ragioni di natura economica e finanziaria, ossia la difesa di interessi corporativi. A differenza per esempio della situazione statunitense, in cui alcuni episodi di pressione delle lobby dell’industria petrolifera sulle politiche climatiche hanno avuto grande risalto, alla base del negazionismo italiano c’è spesso l’esibizionismo, il narcisismo, la ricerca della visibilità che può arrivare dal cantare fuori dal coro. Il problema climatico per altri è uno dei fronti di una battaglia ideologica, volta a difendere a tutti i costi l’attuale concezione dello sviluppo e della produzione, le «magnifiche sorti e progressive»; oppure una visione religiosa dell’uomo e della natura.
L’arretratezza del dibattito sul clima in Italia, rispetto alle sfide che attendono anche il nostro Paese (adattamento ai cambiamenti climatici che si verificheranno, riduzione consistente delle emissioni nei prossimi decenni), è dovuto anche al modo con cui i mezzi di comunicazione hanno informato sui cambiamenti climatici, un modo estremamente ambiguo.
Da un lato stampa e televisione hanno assecondato una voglia diffusa di non credere alle evidenze portate dalla comunità scientifica, i segni dei cambiamenti climatici già in corso e le proiezioni secondo cui in pochi secoli il Pianeta potrebbe essere molto meno vivibile e ospitale per la specie umana.
Dall’altro lato, altrettanto frequenti sono state le esagerazioni, i sensazionalismi per gli sconvolgimenti del clima: per qualche giorno di temperatura sopra la media o un acquazzone prolungato è proposta la responsabilità del cambiamento climatico, fra titoli come “Clima impazzito” e “Fine del Mondo”. Al trasformismo avventuroso delle teorie negazioniste si è opposto il catastrofismo allarmistico, che vede in ogni irregolarità meteorologica il segno dell’inevitabilità della catastrofe.
Il problema climatico in un’ottica plurisecolare, come avvio di processi (la fusione delle calotte polari, l’innalzamento del mare), pericolosi in quanto inarrestabili una volta avviati, interessa molto meno delle carestie, inondazioni e disastri dei prossimi anni. È forse per bilanciare questa scarsa lungimiranza che i rischi per l’immediato vengono invece esasperati, più di quanto i rapporti scientifici effettivamente giustifichino. Numerosi e autorevoli studiosi del problema climatico hanno mostrato come lo sforzo necessario per contrastare i cambiamenti climatici rappresenti qualcosa di epocale, richieda una rapida conversione delle tecnologie con cui si produce e consuma l’energia, nonché una modifica degli stili di vita più impattanti; un cambiamento sostanziale, che sarà facilitato da una maggiore consapevolezza delle cause della crisi climatica e delle responsabilità storiche dei Paesi più industrializzati.
Una sfida, quella dei cambiamenti climatici, quindi molto complessa. In cui si vede anche il rischio della retorica e della semplificazione – che propone come facile panacea la green economy – della fiducia cieca che tutto si sistemerà come si è sempre sistemato, senza cercare di capire i perché dei tanti ritardi accumulati, i motivi strutturali. La semplificazione che non coglie la particolarità della crisi climatica, il suo carattere globale, il suo investire alla radice la necessità di un diverso equilibrio geopolitico, un diverso sviluppo di un paio di miliardi di persone che oggi hanno un accesso molto limitato all’energia. La necessità di una discussione a un livello più profondo, una riflessione sul significato di questa continua corsa alla crescita delle produzioni, dei consumi, dell’uso delle risorse non rinnovabili del Pianeta.
Stefano Caserini
DIIAR, Sez. Ambientale, Politecnico di Milano
http://www.climalteranti.it
Articolo pubblicato sulla rivista bimestrale QualEnergia (n.5/2010)



























.gif)