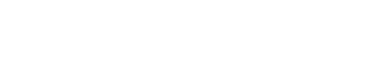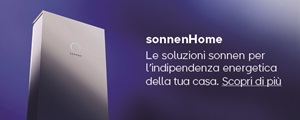In uno scenario mondiale che vede il gas naturale rafforzare il suo ruolo di fonte di transizione verso le fonti rinnovabili, l’Italia si trova in una situazione potenzialmente favorevole avendo spostato gran parte dei propri consumi petroliferi, in particolare nel settore civile e nella produzione elettrica, verso il gas.
Tuttavia, per poter valorizzare tale situazione, mancano tre fondamentali condizioni. La prima, la più grave, è la povertà infrastrutturale. Non ha torto chi ritiene che le famiglie povere siano penalizzate perché non hanno il denaro per approfittare delle svendite e delle promozioni: non potendo fare scorta di prodotti pagano i prezzi che trovano o rinunciano a comprare.
L’Italia del gas è un po’ così. È un’Italia povera di infrastrutture che quando il prezzo è basso non può comprare perché non ha dove stoccarlo e quando il prezzo è alto o paga o non può consumare.
Più volte negli ultimi anni avevamo avuto evidenti e amare dimostrazioni della povertà infrastrutturale in situazioni di prezzi alti: le criticità legate alle carenze infrastrutturali sono state evidenziate con nettezza nel recente passato dalle gravi crisi di approvvigionamento, costate oltre 100 milioni di euro ai consumatori italiani, innescate o da picchi di domanda invernale (crisi del 2004-2005 e del 2005-2006) o da temporanee indisponibilità di importazioni (crisi Ucraina-Russia del 2009).
Nel 2009 per la prima volta si è avuta l’evidenza di tale povertà anche in una situazione di prezzi bassi. In un’estate in cui il gas era disponibile oltrefrontiera a prezzi da saldi, ma i pochi stoccaggi italiani erano già colmi, noi eravamo nella condizione di chi vede passare un gelataio che regala i gelati ma ha il piccolo frigorifero già pieno. Il paradosso è che in tale situazione c’è chi sostiene che l’Italia dovrebbe fermare o ridurre gli investimenti infrastrutturali nel gas naturale.
Ciò introduce la seconda condizione che manca per valorizzare la favorevole situazione italiana nel gas: una strategia del Paese basata su elementi informativi non distorti e su una diffusa consapevolezza. Esemplare a riguardo è appunto la tesi dell’eccesso di offerta, ovvero della cosiddetta “bolla”. Tale tesi, di cui sono chiare le reali finalità anticoncorrenziali, è basata su definizioni distorte della domanda e dell’offerta che tuttavia si presentano suadenti per i non addetti ai lavori.
La tesi si presenta anche semplice: con le attuali infrastrutture abbiamo un’offerta di 120 miliardi di m3/anno e una domanda di 80 miliardi di m3/anno, quindi c’è eccesso di offerta e non servono nuove infrastrutture.
In realtà il fatto che la capacità annuale di importazione e produzione superi la domanda annuale non è il sintomo di una situazione di eccesso di offerta: è solo un requisito tecnico, ovvio e non affatto sufficiente, per soddisfare la domanda. Per valutare con un minimo di correttezza il bilanciamento della domanda e dell’offerta di gas occorre tenere conto del profilo stagionale della domanda almeno in funzione delle esigenze di riscaldamento civile. È necessario quindi analizzare il bilanciamento non a livello annuale ma almeno a livello giornaliero.
L’offerta massima a livello giornaliero è pari alla somma delle capacità di importazione e di produzione nazionale, nel complesso circa 330 milioni di metri cubi al giorno (Mmc/g), nonché della capacità tecnica di erogazione dello stoccaggio. La capacità di erogazione degli stoccaggi è pari a circa 270 Mmc/g quando sono completamente pieni, ma poiché declina rapidamente in funzione del grado di utilizzo, al termine di un inverno mediamente freddo si riduce a circa 120 Mmc/g. Quindi l’offerta massima varia dai circa 600 Mmc/g a inizio inverno ai 450 Mmc/g a fine inverno. Quest’ultimo valore è vicino alla domanda che si realizzerebbe in caso di punte di freddo intenso alla fine della stagione invernale.
È evidente quindi che in questa situazione, che non lascia certamente grandi spazi alla concorrenza, se ai rischi del clima si sommassero altre cause di riduzione dell’offerta invernale come l’interruzione delle importazioni da uno dei principali metanodotti – che hanno capacità dell’ordine degli 80-100 Mmc/g -, il sistema potrebbe non essere in grado di far fronte alla domanda.
Una valutazione non distorta dell’offerta porta a ritenere che in Italia un sistema del gas adeguato all’attuale domanda, in grado sia di creare spazi di competizione tra i Paesi fornitori sia di fronteggiare anche interruzioni invernali prolungate di una delle principali fonti di approvvigionamento, dovrebbe disporre di almeno 80 Mmc/g aggiuntivi di offerta; questo è un valore molto rilevante se confrontato con gli investimenti in corso. Basti considerare che il rigassificatore di Rovigo ha apportato appena 25 Mmc/g aggiuntivi.
STRUTTURE MANCANTI
La situazione di deficit infrastrutturale è quindi con tutta evidenza grave e duratura, visto che altre realizzazioni sono attualmente incerte e comunque spostate nel tempo. È chiaro che questa situazione favorisce i soggetti che, legati dai contratti di lungo termine take or pay, cercano di difendere il proprio mercato da nuovi venditori che più facilmente potrebbero approvvigionarsi sui mercati spot europei; ma questo legittimo interesse dei venditori attuali non coincide con l’interesse dei consumatori italiani.
La terza condizione che manca per valorizzare la favorevole situazione italiana nel gas è un assetto di mercato favorevole alla concorrenza. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas da anni sollecita al riguardo interventi normativi, da ultimo con la segnalazione formulata il 30 gennaio ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, a cui si rimanda per una trattazione più completa. Centrali rimangono le tematiche relative alla situazione proprietaria delle infrastrutture di importazione, stoccaggio e trasporto – oggi ancora sotto il controllo del Gruppo ENI, operatore dominante – e a una loro possibile gestione terza e indipendente a cui attribuire anche i diritti di trasporto sui metanodotti internazionali di adduzione in Italia, detenuti dall’operatore dominante.
È inoltre necessario pervenire, anche attraverso nuovi e più rigorosi tetti antitrust, a una struttura di offerta sufficientemente concorrenziale o, almeno, attuare misure (gas release pluriennali) che inducano un comportamento di offerta concorrenziale; questa è una condizione fondamentale perché un’eventuale futura Borsa del gas possa produrre i suoi benefici effetti. Diversamente, i segnali di prezzo prodotti resteranno non solo fortemente distorti ma anche facilmente condizionabili da parte dell’operatore dominate e senza costo rilevante.
La stessa condizione è indispensabile anche con riferimento al ruolo che potrebbe assumere l’Acquirente unico nel mercato del gas naturale per l’approvvigionamento sul mercato del gas naturale destinato ai clienti finali di minori dimensioni: nell’attuale contesto di mercato i prezzi di acquisto potrebbero riflettere, verosimilmente, solo l’esercizio di potere di mercato dell’operatore dominante. L’assenza di mercati liquidi continua peraltro a condizionare non solo gli esiti del mercato all’ingrosso, ma anche il forte grado di integrazione verticale che ancora caratterizza l’attività di vendita al dettaglio e ne compromette il grado di concorrenza.
L’esistenza di centinaia di imprese di distribuzione e la conseguente necessità, per i venditori che vogliano espandere la propria azione sul territorio, di moltiplicare le relazioni e gli scambi di dati necessari alla gestione dei contratti di trasporto e distribuzione, frena la spinta ad acquisire nuovi clienti e favorisce le imprese di vendita collegate al distributore locale.
LE DIMENSIONI CONTANO
Quindi al maggior onere per i consumatori, connesso alla ridotta dimensione delle imprese di distribuzione, si somma quello indotto dalla barriera all’ingresso di nuovi operatori.
In più circostanze l’Autorità ha auspicato che si pervenisse a un assetto delle concessioni di distribuzione che riducesse sensibilmente il numero degli ambiti di concessione. In questo senso il recente schema di decreto interministeriale, cui l’Autorità ha dato il proprio parere favorevole, prevede un numero di ambiti di concessione che, sebbene sia superiore a quanto a suo tempo indicato dall’Autorità, consente in ogni caso di porre in atto un significativo e positivo riordino verso un assetto ottimale.
Ogni argomento proposto per frenare o ridurre la portata della riforma dovrebbe almeno avere come presupposto la disponibilità da parte delle imprese di distribuzione minori a percepire le stesse tariffe (più basse) e a fornire la stessa qualità del sevizio (più alta) delle imprese più grandi ed efficienti: senza questo presupposto ogni argomento rimane una comprensibile ma poco credibile difesa corporativa. In definitiva, lo scenario del gas è cambiato ma affinché l’Italia ne possa trarre tutti i possibili vantaggi è necessario avere la volontà e la forza, anche qui, di cambiare.
Tullio Fanelli (Commissario Autorità per l’energia e il gas)
Leggi prima parte dell’articolo “Come cambia il gas“
25 maggio 2010



























.gif)