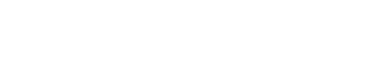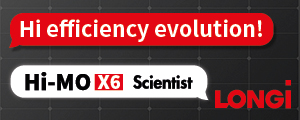In Italia l’EurObserv’ER stima per il 2007 una produzione di biogas di 406,2 ktep (circa 4,7 TWh); di questa, oltre l’85% è ottenuta dal recupero di biogas dalle discariche per rifiuti urbani. Il Gse, per il 2007, riporta una produzione lorda di energia elettrica da biogas di 1,45 TWh, di cui circa l’86% è ottenuta dal biogas da discariche per rifiuti urbani.
Nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, il Crpa (Centro ricerche produzioni animali) ha svolto un censimento degli impianti di digestione anaerobica operativi su tutto il territorio nazionale nel settore zootecnico e agro-industriale, al fine di creare un archivio capace di fornire un quadro completo della dimensione del settore in Italia e delle principali caratteristiche degli impianti. Il settore è in forte espansione, sia dal punto di vista della costruzione di nuovi impianti che della costituzione di nuove ditte o nuovi ambiti di impresa interessati alla realizzazione di impianti completi e/o di componentistica.
All’ottobre 2007 sono stati rilevati 185 impianti di biogas che operano con effluenti zootecnici, colture energetiche, residui organici, reflui dell’agro-industria e la frazione organica dei rifiuti urbani. In questo numero sono compresi anche gli impianti in attesa di autorizzazione e in costruzione. La maggior parte degli impianti censiti, ovvero 154 (tabella 1), opera con effluenti zootecnici, scarti agricoli, residui agroindustriali e colture energetiche.
Gli impianti in attività che utilizzano effluenti zootecnici sono 115. Rispetto a un precedente censimento del 1999, questo numero è aumentato di circa 43 unità (+60%) e di 78 unità (+108%) se si considerano anche quelli attualmente in fase di realizzazione; questo conferma il forte impulso che la digestione anaerobica sta avendo nel nostro Paese.
Dall’indagine è risultato che gli impianti sono realizzati per la quasi totalità nelle Regioni del Nord. Le aree più interessate risultano essere quelle in cui è presente una maggiore concentrazione di allevamenti zootecnici come la Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Veneto; alcuni impianti si stanno pure sviluppando in zone in cui sono prodotte quantità significative di scarti e sottoprodotti organici del comparto agro-industriale da utilizzare in co-digestione, anche come soluzione gestionale al recupero di questi scarti. La quantità di impianti presente in Provincia di Bolzano è sicuramente influenzata dalla vicinanza con l’Austria e la Germania, oltre che dalla forte politica di incentivazione dell’amministrazione provinciale. Il numero di impianti risulta invece decisamente più contenuto nel Centro e nel Sud dell’Italia.
Dal censimento risulta consistente la presenza di impianti che utilizzano solo liquame suino; alcuni di questi rappresentano la generazione di impianti di biogas semplificati realizzati principalmente a inizio degli anni ’90 sovrapponendo una copertura di materiale plastico a una vasca e/o laguna di stoccaggio dei liquami. Successivamente, anche in Italia si è mostrato interesse alla co-digestione dei liquami zootecnici in miscela a biomasse, come colture energetiche e scarti organici.
Relativamente alla tipologia di reattori prevale decisamente quella della vasca a pareti verticali miscelata e coibentata (Cstr = Completely Stirred Tank Reactor), nella maggior parte dei casi realizzata in cemento armato. Il reattore a flusso orizzontale a pistone (Pfr = Plug Flow Reactor) risulta prevalente soprattutto dove vengono trattati i liquami suini da soli.
Il volume dei digestori è nella maggior parte dei casi compreso tra 1.000 e 5.000 m3 e il tempo di ritenzione idraulica prevalente è tra 16 e 25 giorni. Riguardo la temperatura maggiormente utilizzata – negli impianti nei quali è stato rilevato tale dato – è compresa tra 30 e 40°C (mesofilia). Inoltre sono stati rilevati 8 impianti che lavorano con temperature superiori a 50°C (termofilia).
Per quanto riguarda l’utilizzo del biogas, negli impianti per effluenti zootecnici prevale la cogenerazione; solo in 8 impianti – tra quelli per i quali si è ricevuta l’informazione, ma il numero probabilmente è superiore – in genere annessi a caseifici per la produzione di Grana Padano o Parmigiano Reggiano, il biogas viene bruciato direttamente in caldaia per la sola produzione di calore. Dei 154 impianti che trattano effluenti zootecnici, scarti agricoli e agro-industriali e colture energetiche, la maggior parte hanno una potenza elettrica installata inferiore a 100 kWe e 14 maggiore di 1 MWe, per un totale di circa 49 MWe installati, negli impianti per cui il dato è disponibile.
Sono stati rilevati 7 impianti di trattamento della frazione organica pre-selezionata da raccolta differenziata (Forsu), da sola o in miscela con fanghi di depurazione, e 2 impianti che effettuano il trattamento della frazione organica da selezione meccanica in miscela con fanghi di depurazione. Tra gli impianti che utilizzano effluenti zootecnici ci sono anche altri 4 impianti (di cui uno in costruzione e uno in fase autorizzativa) che trattano Forsu insieme a liquami, pollina, fanghi agro-industriali e colture energetiche.
Relativamente agli impianti di digestione anaerobica per la stabilizzazione dei fanghi di depurazione civile e industriale – realizzati per lo più all’interno di grossi impianti urbani di depurazione delle acque reflue civili e industriali – sulla base di un precedente censimento (Gerli A., Merzagora W., 2000) si stimano più di 120 impianti di grandi dimensioni.
Notevole pure il recupero dalle discariche per rifiuti urbani, che grazie a circa 183 impianti operativi e circa 297 MWe installati (dati Gse al 31/12/2007) rappresenta, per ora, la principale fonte di biogas da biomasse.
Per completare la panoramica, in tabella 2 e in figura 1 è riportato il numero di impianti di biogas per ciascuna Regione e per ciascuna categoria comprensivo di quelli che non trattano matrici di origine agricola o agro-industriale; sono comunque esclusi gli impianti di recupero del biogas dalle discariche dei rifiuti urbani.
AZIONI DI SVILUPPO
Dalla possibilità di trasformare le biomasse dedicate e di scarto in energia (biogas) e in fertilizzanti, contribuendo a ridurre l’inquinamento, deriva l’utilità anche in Italia di:
-
favorire la realizzazione di impianti di biogas negli allevamenti zootecnici. Particolarmente interessante è l’utilizzo del biogas per cogenerare energia elettrica ed energia termica. Degna di attenzione è anche la possibilità di digerire, assieme agli effluenti zootecnici, le colture energetiche (in particolare mais e sorgo zuccherino), i residui colturali e i sottoprodotti dell’agroindustria, aumentando la resa energetica degli impianti;
-
potenziare e razionalizzare i digestori anaerobici dei fanghi derivanti dalla depurazione di acque reflue civili (presenti in tutti i grandi impianti di depurazione urbani), favorendo la codigestione anche di liquami zootecnici e scarti organici agroindustriali;
-
attivare, viste le sollecitazioni che vengono dalla necessità di gestire crescenti quantità di frazioni organiche derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, progetti di codigestione anaerobica di queste biomasse assieme ai liquami zootecnici e/o ai fanghi di depurazione;
-
avviare, visto il crescente problema della collocazione degli scarti di macellazione e gli indirizzi contenuti nel regolamento CE 1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, la codigestione di liquami zootecnici, scarti di macellazione adeguatamente pretrattati e altre biomasse;
-
facilitare l’integrazione dei processi anaerobici e aerobici nel trattamento delle biomasse e dei rifiuti organici, sia nella costruzione di nuovi impianti che nel potenziamento di impianti già esistenti quali, ad esempio, gli oltre 100 impianti di compostaggio di media e grossa taglia già operanti in Pianura Padana nelle vicinanze dei siti di produzione di scarti organici agroindustriali e di effluenti zootecnici;
-
favorire l’utilizzo del biogas, dopo purificazione a metano al 95-98% (l’anidride carbonica recuperata è a sua volta un gas tecnico richiesto dal mercato), per autotrazione e immissione nella rete di distribuzione del gas naturale; ciò dovrebbe essere incentivato in particolare nelle regioni padane dove la rete dei metanodotti è capillarmente diffusa ed è già esteso l’uso del metano per autotrazione (oltre 400.000 veicoli già circolanti).
CONCLUSIONI
Nel corso degli ultimi dieci anni la digestione anaerobica si è diffusa in molti Paesi europei, tra cui anche l’Italia. Questi impianti vengono realizzati non solo allo scopo di recuperare energia rinnovabile, il biogas, ma anche per controllare le emissioni maleodoranti e per stabilizzare le biomasse prima del loro utilizzo agronomico.
In Italia la normativa sugli incentivi all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (certificati verdi) ha suscitato un rinnovato interesse verso gli impianti di biogas. Un ulteriore impulso può venire dall’evoluzione della politica ambientale, che riguarda pure il settore della valorizzazione energetica delle biomasse, attivatosi a seguito della Conferenza di Kyoto sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico da gas serra. Inoltre, possono accentuare l’attenzione sul recupero del biogas anche il regolamento CE 1774/2002 sui sottoprodotti di origine animale, che individua la digestione anaerobica e il compostaggio come i due processi biologici che ne consentono la valorizzazione energetica e il riciclo come fertilizzanti, e la nuova Politica agricola comunitaria (Pac), che incentiva le colture energetiche.
Il coincidere di problematiche quali l’effetto serra, la valorizzazione degli scarti organici, la richiesta di maggior contributo di energie rinnovabili sta quindi facendo emergere nuove opportunità che il mondo agricolo potrebbe essere interessato a cogliere. In particolare, il settore zootecnico può rappresentare la forza motrice per lo sviluppo su larga scala della digestione anaerobica, come già sta avvenendo in Germania, Danimarca, Svezia e Austria. Gli incentivi in tal senso sono molti: un miglioramento della “sostenibilità ambientale” degli allevamenti, un’integrazione di reddito “dall’energia verde”, una riduzione dei problemi ambientali legati alle emissioni in atmosfera e agli odori, una migliore utilizzazione agronomica degli elementi fertilizzanti presenti nei liquami.
Da ciò deriva l’utilità di potenziare e di razionalizzare i sistemi che sfruttano processi di co-digestione anaerobica di biomasse di varia natura.
Affinché le opportunità possano essere pienamente colte, però, è necessario che la realizzazione di impianti di biogas, l’allacciamento alla rete elettrica nazionale e l’utilizzazione delle varie matrici sottostiano a procedure autorizzative più chiare e percorribili di quelle attualmente in vigore; inoltre, deve essere assicurato l’utilizzo agronomico del digestato anche quando si co-digeriscono liquami zootecnici con colture energetiche e scarti organici selezionati.
Importante è anche il contributo che la digestione anaerobica può fornire per l’autosostentamento energetico di impianti di trattamento finalizzati alla riduzione del carico azotato dei liquami zootecnici prodotti in Zone Vulnerabili ai sensi della Direttiva Nitrati.
Infine, la realizzazione di impianti di biogas può avere buone prospettive se si favorisce l’utilizzo del biogas, dopo purificazione a metano al 95-98%, per l’autotrazione e l’immissione nella rete di distribuzione del gas naturale.
Sergio Piccinini
CRPA – Centro Ricerche Produzioni Animali, Reggio Emilia
3 febbraio 2010