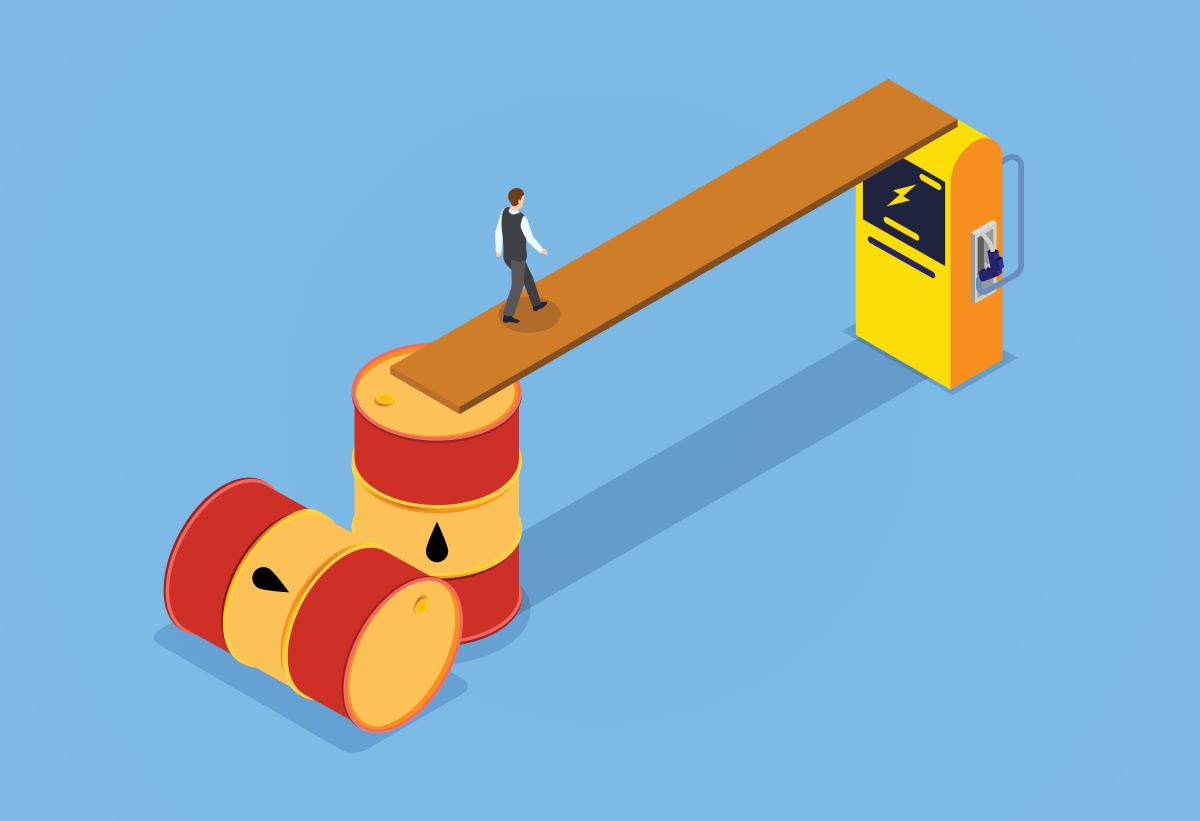Nel giro di pochi anni la questione climatica è diventata la principale preoccupazione ambientale e sta condizionando in maniera sempre più incisiva le scelte economiche dei paesi industrializzati, e non solo di quelli.
Nel giro di pochi anni la questione climatica è diventata la principale preoccupazione ambientale e sta condizionando in maniera sempre più incisiva le scelte economiche dei paesi industrializzati, e non solo di quelli.
I più attenti osservatori ritengono comunque che una risposta è ancora possibile e che anzi una strategia intelligente potrà aprire nuove aree di sviluppo nell’economia del pianeta.
Così la pensa Schwarzenegger, che ha ricordato alle Nazioni Unite come la California, dopo i successi economici indotti prima dall’industria aerospaziale e poi dall’informatica, si appresta ora a cavalcare il boom delle tecnologie verdi.
La transizione energetica non sarà però indolore e si intersecherà nei prossimi 10-20 anni con altre possibili crisi, ad iniziare dal raggiungimento del picco della produzione di greggio.
E’ chiaro che la decarbonizzazione delle economie indurrà cambiamenti profondi nelle modalità di produzione e consumo dell’energia. Ricordiamo infatti che, a fronte di un probabile incremento delle emissioni di anidride carbonica del 50% tra il 1990 e il 2010 (malgrado Kyoto), si dovrebbe arrivare entro una ventina di anni ad una stabilizzazione delle emissioni e poi ad una loro progressiva riduzione per giungere ad un dimezzamento entro una cinquantina di anni. Per lo meno questo è il percorso indicato dalla comunità scientifica e ormai accettato da molti importanti leader politici.
E’ però evidente l’attuale schizofrenia tra un andamento tendenziale che porterebbe ad un incremento del 50% delle emissioni climalteranti entro il 2030 e la necessità invece di drastici tagli.
Ma quali sono le reali dinamiche in atto? I paesi industrializzati sono responsabili della quota principale delle emissioni di CO2 (oltre l’80% nel 1975 e il 59% nel 2005), ma la situazione tenderà a ribaltarsi con i paesi in via di sviluppo che prima del 2020 supereranno i paesi ricchi.
Dunque occorre definire dei meccanismi semplici e convincenti che consentano di coinvolgere tutti i paesi del pianeta nel percorso di contenimento delle emissioni, pur con obbiettivi differenziati. Si deve cioè andare oltre agli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto limitati ai paesi industrializzati (5% di emissioni climalteranti in meno nel quinquennio 2008-12 rispetto al 1990).
Naturalmente si dovrà trovare un accordo sulle modalità di ripartizione degli obbiettivi. “Contraction and convergence” rappresenta una proposta suggestiva che prevede un livello di emissioni pro capite uguale per tutti entro la fine del secolo. Il raggiungimento di questo obbiettivo (rilanciato recentemente dalla Merckel con un ipotesi di 2 t annue per abitante, pari alla metà della attuale media mondiale) comporta un rapido calo delle emissioni dei paesi industrializzati ed un incremento sempre minore per quelle dei paesi in via di sviluppo in modo da raggiungere un picco entro il 2025-2030 per poi calare.
Gli impatti del clima: chi vince e chi perde
Nell’ultimo rapporto dell’Ipcc si evidenzia il fatto che i rischi riguardano soprattutto i paesi in via di sviluppo meno in grado di adattarsi agli impatti previsti. Alcune aree dell’emisfero nord potranno anche godere di alcuni benefici per modesti incrementi di temperatura, ma per aumenti superiori ai 2 °C le conseguenze negative sarebbero generalizzate.
Estraiamo dal rapporto alcune delle valutazioni sulle quali si è raggiunto un elevato consenso tra gli scienziati.
“Nell’Europa meridionale, i cambiamenti climatici potrebbero causare un peggioramento delle condizioni (alte temperature e siccità) in una zona già vulnerabile alla variabilità climatica. L’Africa è uno dei continenti più vulnerabili .. secondo le proiezioni al 2020, 75-250 milioni di persone saranno esposte ad un incremento dello stress idrico. La disponibilità di acqua nell’Asia, particolarmente nei grandi bacini fluviali, potrà diminuire …e causare impatti negativi a più di un miliardo di persone al 2050…..sono previste inondazioni annuali che interesseranno milioni di persone a causa del sollevamento del livello del mare. Vi è il rischio di un aumento dell’instabilità del terreno nelle regioni con permafrost”.
L’affinamento dei modelli e delle misurazioni ha consentito di aumentare la capacità predittiva e di restringere i margini di incertezza. Se pure c’è un consenso crescente sulle posizioni dei rapporti dell’Ipcc, esiste/resiste ancora una minoranza scettica che mette in discussione lo stesso ruolo dell’uomo nelle alterazioni climatiche ed un’altra minoranza, sul versante opposto, che riteniene ormai la situazione fuori controllo. Tra questi James Lovelock, il propugnatore della teoria di Gaia, che propone un rilancio massiccio del nucleare temendo milioni di morti nel corso del secolo. A preoccuparsi per gli esiti catastrofici di una accelerazione del riscaldamento del pianeta troviamo anche il Pentagono che in uno studio del 2003 mette a fuoco i rischi per la sicurezza degli Usa legati alla migrazione forzata di intere popolazioni.
Per concludere, i segni di un cambiamento sono sempre più visibili e non si può escludere che il fenomeno possa accelerarsi con riflessi anche sulla tenuta democratica dei nostri sistemi.
I meccanismi flessibili: un’opportunità per il trasferimento di tecnologie pulite?
Per facilitare il raggiungimento degli obbiettivi di riduzione delle emissioni al minor costo, il protocollo di Kyoto prevede infatti l’utilizzo di strumenti che consentono di effettuare investimenti in paesi via di sviluppo (Clean Development Mechanism, CDM) o in paesi con economie in transizione (Joint Implementation, JI) e di contabilizzare i crediti di carbonio nei paesi industrializzati.
Questo uso dei “meccanismi flessibili” ha creato un mercato in forte crescita, con transazioni che si sono decuplicate nel giro di due anni raggiungendo un valore di 5,4 Miliardi $ nel 2006. Complessivamente gli investimenti che hanno dato luogo a questi certificati sono stati 3 volte più elevati.
In realtà, finora, gli interventi che hanno portato ad un maggior numero di certificati sono stati legati all’eliminazione dell’HFC23 e del protossido di azoto, entrambi gas con elevatissimo effetto climalterante, ma nei prossimi anni si dovrebbero passare all’innalzamento dell’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili con un trasferimento di know how e di tecnologie per decine di miliardi di euro.
Seguire l’evoluzione di questo mercato è dunque importante perché si potrebbe avviare una gigantesca dislocazione di tecnologie pulite, favorendo la sostenibilità dello sviluppo in aree povere del pianeta.
Concentrandosi sul quinquennio di Kyoto, si ritiene che i paesi industrializzati avranno un deficit dell’ordine di 3,3 miliardi di t CO2eq (tonnellate equivalenti di anidride carbonica, considerando le emissioni di tutti i gas climalteranti espressi in CO2 in funzione del loro effetto schermante).
Ci sono tre modi di ridurre questo gap. Il primo risiede in una accelerazione dei programmi nazionali. Una seconda strada punta all’acquisizione di crediti derivanti da progetti CDM o JI, opzione che, come si è visto, viene utilizzata in maniera rapidamente crescente. Ma c’è una terza ipotesi che deriva dalla vendita di circa 6-7 miliardi di tCO2eq da parte dei paesi dell’Est che all’atto della firma del Protocollo avevano emissioni molto inferiori rispetto al target assegnato. Dunque la immissione sul mercato di queste quote depotenzierebbe il mercato dei CDM e dei JI. La variabile “aria fritta”, è ancora indefinita nei suoi contorni e potrà influenzare notevolmente le transazioni dei prossimi anni.
Ma vediamo qual è la situazione attuale. I progetti CDM finora registrati, fine di giugno, dovrebbero generare certificati per 1 miliardo t entro il 2012, mentre progetti per altri 1,2 miliardi di t sono stati presentati alle autorità competenti ma non sono ancora stati approvati. Come si vede, questo strumento potrebbe coprire una larga parte del gap di carbonio dei paesi industrializzati in difficoltà.
Al fine di favorire una più ampia partecipazione nella fase post-Kyoto, si potrebbe poi studiare un meccanismo che consenta di valorizzare maggiormente i crediti provenienti da progetti effettuati in paesi che accettino obbiettivi di contenimento delle emissioni dopo il 2012.
L’efficacia di questi meccanismi potrebbe estendersi quindi notevolmente nei prossimi decenni favorendo un forte trasferimento di tecnologie verso i paesi invia di sviluppo. Quello che non sono riusciti a fare gli impegni ad aumentare gli aiuti ai paesi in via di sviluppo sempre promessi, potrebbe riuscire grazie alla preoccupazione che emissioni fuori controllo nel sud del mondo facciano saltare gli equilibri del pianeta e quindi anche il benessere dei paesi ricchi.
Quali atteggiamenti nei confronti del post Kyoto?
Vediamo una panoramica delle posizioni esistenti, prima di approfondire la situazione degli attori principali.
Gli Stati Uniti sono grandi consumatori di energia e temono che una forte riduzione delle emissioni intacchi il loro stile di vita; perplessità vengono anche dal vicino Canada esportatore di energia e con emissioni crescenti che però, al contrario degli Usa, ha ratificato il Protocollo di Kyoto.
L’Europa, importatrice di fossili ma con una intensità energetica ridotta, ritiene che lo sviluppo di tecnologie alternative possa rappresentare un’area di business e si colloca alla testa dello schieramento impegnato sul fronte del clima.
La Russia fa prevalere l’interesse di grande potenza esportatrice di idrocarburi e non si considera troppo a rischio dalle conseguenze del riscaldamento del pianeta, mentre la Cina, importatrice vorace di energia e con emissioni elevate, inizia a temere le conseguenze climatiche e, pur essendo restia a prendere impegni, auspica un trasferimento di tecnologie pulite. Una posizione analoga è riscontrabile in India.
Molti altri paesi in via di sviluppo sempre più a rischio per il cambiamento del clima e con bassi consumi ed emissioni auspicano un accordo che possa contribuire a ridurre i rischi e faciliti l’impiego di tecnologie e know-how.
I paesi produttori di petrolio sono invece di solito ostili ad impegni internazionali sulle emissioni che rischiano di limitare le entrate. L’Australia, grande esportatore di carbone non ha ratificato Kyoto, analogamente agli Usa, ma potrebbe cambiare posizione dopo le elezioni di novembre. Perché poi c’è la politica. Quale sarebbe stata la posizione statunitense se Al Gore fosse diventato presidente vincendo il contenzioso legato alla manciata di voti contesi in Florida?
Per completare il quadro, è interessante riportare il giudizio delle associazioni ambientaliste presenti alle varie convenzioni del clima. A partire dal 1999 è stato infatti assegnato il premio “Fossil of the day” allo Stato che, giorno dopo giorno, si era comportato peggio nelle trattative. La palma d’oro come numero di giudizi negativi è andata agli Stati Uniti, seguiti da Canada, Arabia Saudita, Giappone ed Australia.
Ma vediamo più in dettaglio la posizione di alcuni paesi.
Unione Europea
L’Europa si è, tra l’altro, dotata di uno strumento di mercato mutuato dagli Usa, l’Emissions trading, applicato ai settori energivori con la definizione di tetti massimi di produzione di anidride carbonica per le varie industrie e la possibilità di acquisire al minor costo le riduzioni mancanti. Lo schema ha creato, pur con i suoi limiti iniziali, un mercato della CO2 e viene osservato con attenzione anche in altri continenti.
Ma forse l’aspetto più interessante della UE è dato dalla capacità straordinaria che ha avuto di “cogliere l’onda” creando nuovi settori economici nel campo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica. Basti ricordare che in pochi anni Germania e Spagna hanno visto la nascita di migliaia di imprese verdi con 315.000 addetti.
E questo trend dovrebbe accelerarsi. La definizione infatti dell’ambizioso obbiettivo del 20% dei consumi energetici da fonti rinnovabili entro il 2020 dovrebbe estendere la rivoluzione energetica a tutti i 27 paesi dell’Unione. Basti osservare che gli investimenti necessari per innalzare la percentuale delle rinnovabili e dell’efficienza energetica saranno molto più elevati rispetto al passato e potrebbero superare le risorse tradizionalmente indirizzate verso il potenziamento del settore termoelettrico.
Russia
Alcuni scienziati, come il co-responsabile della delegazione russa all’IPCC Yuri Izrael, hanno fino a poco tempo fa messo in discussione la gravità del riscaldamento del pianeta. E il consigliere economico di Putin, Illarionov, considerava la ratifica del Protocollo una vera sciagura.
In questo contesto il presidente russo ha tirato a lungo la corda sulla ratifica del Protocollo di Kyoto, cercando di ottenere in cambio dall’Europa un sostegno rispetto all’entrata del suo paese nel WTO.
Eppure la Russia aveva tutto da guadagnare grazie all’obbiettivo estremamente generoso che le era stato attribuito a Kyoto (stabilizzazione delle emissioni rispetto al 1990), a fronte di una produzione di CO2 che nel 1995 era del 35% inferiore al 1990 e che nel 2010 malgrado la recente ripresa economica dovrebbe mantenersi del 20% più bassa, consentendo al paese una vendita di quote che potrebbe valere diversi miliardi €. Oltre a ciò, la Russia poteva utilizzare il meccanismo della Joint Implementation che avrebbe facilitato l’acquisizione di tecnologie e di know-how.
Tutti questi elementi hanno avuto un loro peso nel spingere la Russia, nel 2004, a ratificare il trattato che in tal modo entrava in vigore. Il Protocollo, dopo la defezione degli Usa, non poteva infatti avere valore legale senza la partecipazione russa, visto che era necessaria l’adesione di paesi con emissioni pari al 55% del totale del mondo industrializzato.
Malgrado la ratifica, l’attenzione al Protocollo è stata limitata. Secondo Anatoly Chubais la lentezza nel definire le procedure per i progetti JI ha fatto perdere alla Russia investimenti per centinaia di milioni di dollari.
La sensazione generale è comunque che la tematica del clima abbia decisamente una priorità bassa nelle politiche governative (e più in generale nell’opinione pubblica), tese invece a giocare il rilancio del paese sulle esportazione delle risorse energetiche.
Le scelte che verranno effettuate nei prossimi anni sull’utilizzo dei crediti di CO2 avranno un grande impatto sul commercio internazionale del carbonio, considerando che questi sono dello stesso ordine di grandezza della domanda di carbonio da parte degli altri paesi che hanno ratificato il Protocollo. E’ evidente che la quantità di quote che verranno messe sul mercato saranno decisive nel definire il prezzo della CO2. E’ comunque probabile che la Russia pensi di fare un’operazione di “banking”, utilizzando una parte dei crediti in suo possesso per la fase successiva al 2012.
La discussione sul post Kyoto non si è ancora avviata nel paese, ma chiaramente la posizione russa sarà influenzata dall’impatto che un futuro accordo climatico avrà sulle prospettive delle esportazioni energetiche.
Usa
Ci sono molti elementi che fanno pensare che gli Usa rientreranno in gioco con il cambio della guida del paese nel 2009. Basta seguire l’evoluzione di Bush che nel 2000 metteva in dubbio la responsabilità dell’uomo rispetto al riscaldamento del pianeta e nell’ultimo incontro di Washington dello scorso settembre ha invitato tutti i paesi ad impegnarsi, pur continuando a contrastare la definizione di obblighi precisi.
In realtà questo mutamento deriva da una serie di fattori che rendono sempre più insostenibile la posizione defilata dell’Amministrazione. Intanto la crescente spinta dal basso. Un numero sempre maggiore di Stati e oltre 400 città hanno deciso unilateralmente propri obiettivi di riduzione. Ad esempio, sulla costa occidentale si è formata la Western Climate Iniziative, i cui Stati lo scorso agosto hanno deciso di ridurre entro il 2020 del 15% le emissioni di anidride carbonica rispetto al 2005. E analoga sensibilità sta emergendo negli Stati della costa Est.
Poi c’è il mondo degli affari che ha iniziato a manifestare la propria insofferenza rispetto ad un atteggiamento di chiusura che rischia di essere controproducente. Un esempio del cambio di atteggiamento è dato dalla creazione del Business Environmental Leadership Council che riunisce 44 grandi aziende con 3,8 milioni di addetti che vogliono intervenire subito e giudicano Kyoto un primo passo: molte di queste aziende, come General Electric, Du Pont, Ibm, Novartis, hanno anche fissato propri obbiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti.
Forse il più esplicito a manifestare il proprio disagio è stato Jim Rogers, un gestore di centrali a carbone, favorevole ai tetti di emissione negli Usa: “bisogna essere credibili per sedersi al tavolo delle trattative, e se non sei al tavolo ti ritrovi nel menu..”.
Ma non c’è solo la motivazione economica. Ci sono, ad esempio, le posizioni del mondo religioso, inclusi autorevoli rappresentanti della chiesa evangelica tradizionalmente vicina a Bush, che ritengono immorale il mancato intervento.
Insomma, la politica sul clima di questa Amministrazione è sotto accusa e questo tema può diventare importante nella campagna elettorale in atto, come dimostra la recente uscita del democratico Obama che punta su una riconversione energetica nella quale investire 150 miliardi $ nei prossimi 10 anni. Senza contare l’effetto sulle elezioni che avrà l’assegnazione del Nobel per la Pace a Al Gore, indipendentemente da una sua eventuale entrata in campo.
Dunque, tutto fa pensare che nel 2009, con il nuovo presidente Usa si inaugurerà anche una nuova politica sul clima.
Cina
Se la crescita della produzione di CO2 è impressionante, i margini di intervento sono enormi. Tra il 1980 e il 2000 l’intensità energetica si è ridotta al ritmo annuo del 5,2%. E c’è ancora molto da fare. Si consideri, ad esempio, che la Cina produce un terzo dell’acciaio mondiale e emette la metà dell’anidride carbonica associata con questa lavorazione.
Al contrario della Russia però, la preoccupazione sugli impatti climatici è più alta. La riduzione dei ghiacciai e della portata dei fiumi, l’aumento della desertificazione, gli effetti sulla produzione agricola, l’impatto dei tifoni su coste densamente abitate che devono, tra l’altro, fare i conti con l’innalzamento degli oceani, sono tutti elementi che vengono valutati politicamente.
Lo scorso giugno è stato pubblicato il primo Programma nazionale sui cambiamenti climatici. Entro il 2010 si conta di portare la quota di rinnovabili al 10%, di ridurre l’intensità energetica del 20% e di aumentare del 20% la superficie forestale. In termini di emissioni l’incremento delle rinnovabili consentirebbe di ridurre 60 Mt CO2 e le misure di efficienza energetica una quantità dieci volte superiore, 550 Mt.
Per quanto riguarda le opzioni disponibili, due sono già praticate ed avranno un ruolo essenziale. Parliamo delle fonti rinnovabili che nei prossimi decenni copriranno quote importanti della domanda mondiale (in particolare con tecnologie solari abbinate alla produzione di idrogeno) e dell’efficienza energetica, la soluzione meno costosa e più efficace di riduzione delle emissioni.
Poi c’è l’opzione nucleare che sta conoscendo un nuovo revival, perlomeno nelle aspettative di un numero sempre maggiore di politici e di industrie del settore. Perché il contributo di questa tecnologia sia incisivo occorre però che si superino una serie di problemi (sicurezza, smaltimento delle scorie, proliferazione atomica, costi), cosa che forse sarà possibile con i reattori di quarta generazione, cioè fra 20-30 anni.
Resta poi il sequestro dell’anidride carbonica, soluzione fortemente caldeggiata dalle multinazionali petrolifere e del carbone, che potrebbe essere decisiva in realtà come quella cinese. Fra una decina di anni si potrà capire quali sono i reali costi di questa opzione e se ci sono rischi sul fronte della sicurezza.
Ma, aldilà delle varie tipologie di riduzione delle emissioni, saranno decisive le modalità di coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo e il gigantesco trasferimento di tecnologie che si dovrà avviare.
Sempre che non abbiano ragione i pessimisti e il riscaldamento del pianeta non subisca una brusca accelerazione. In questo caso, dopo le guerre del petrolio e dell’acqua, dovremo gestire i conflitti climatici.
Gianni Silvestrini23 novembre 2007