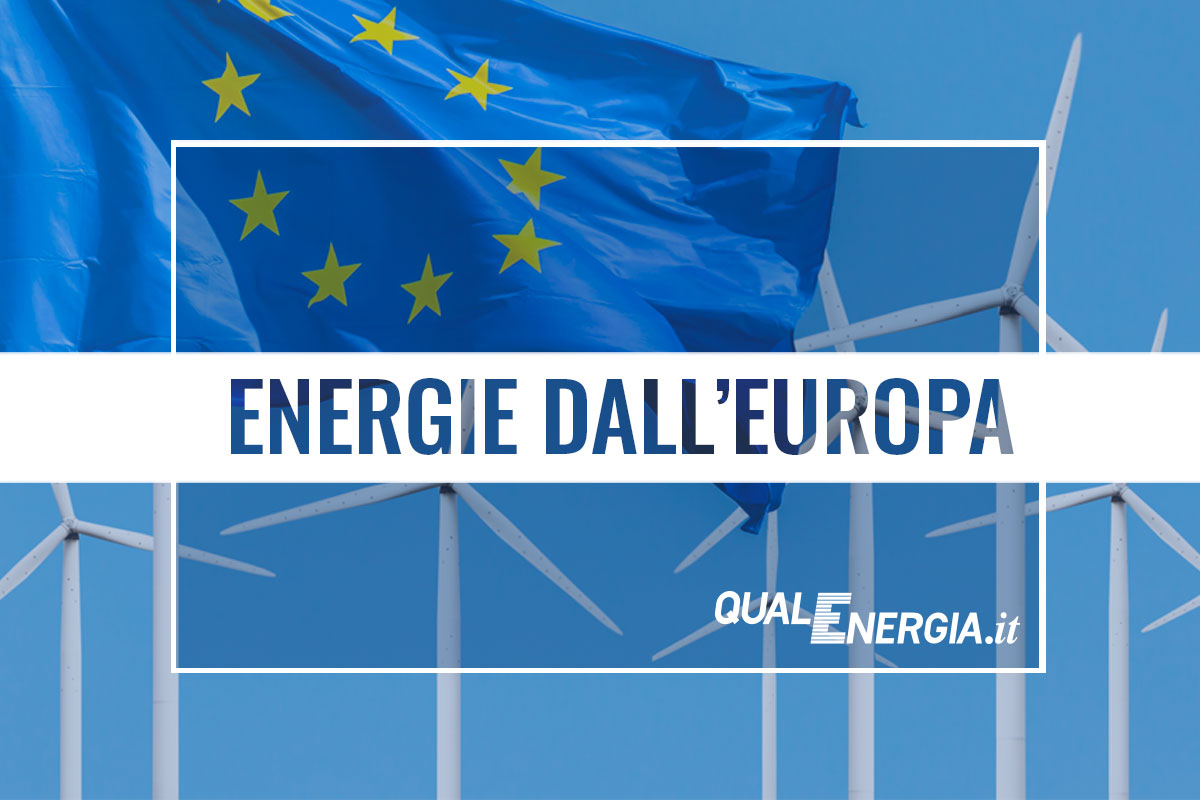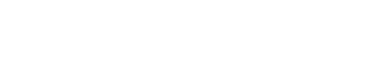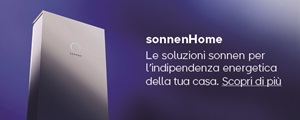A una diminuzione dell’1% dell’ozono colonnare, infatti, corrisponde un aumento delle radiazioni ultraviolette pari all’1,2% a livello del suolo e poiché i raggi Uv-B sono in grado di compromettere sia il Dna, sia l’Rna, apparve subito chiaro che una maggiore esposizione ai raggi ultravioletti avrebbe avuto come conseguenza un forte aumento di forme tumorali, specialmente quelle della pelle come i melanomi. Oggi a due decenni dalla firma di Montreal la produzione di Cfc a livello mondiale è decisamente ridotta – il 2% rispetto al picco del 1988 (dato del 2004) e da circa un anno si sta registrando un lieve, ma costante, miglioramento della consistenza dello strati d’ozono sul Polo Sud.
Ma il Protocollo di Montreal ha avuto delle conseguenze, all’epoca inaspettate, anche sul riscaldamento globale. Le sostanze dannose allo strato dell’ozono (Ods, ozone depleting substance) infatti avevano anche un alto valore rispetto al potenziale di riscaldamento globale (Gwp, Global warming potential) fattore questo che “misura” il contributo di una sostanza all’effetto serra. I Cfc, le sostanze messe al bando dal Protocollo di Montreal possiedono un Gwp compreso tra 4.000 e 14.000, ossia una tonnellata di questi gas in atmosfera ha un effetto sul riscaldamento globale uguale a quello prodotto da 4.000 o 14.000 tonnellate di CO2.
Passo doppio
Questo è un punto che non è mai stato valutato a fondo poiché all’epoca del Protocollo di Montreal non erano ancora ben chiari a livello scientifico come e quanto influivano i vari gas di origine antropica sul riscaldamento globale, mentre quando si definì il protocollo di Kyoto, nel 1997, si diede per scontato, visto che Montreal era stato ratificato e che dal 1994 si era iniziata a vedere una diminuzione nell’atmosfera delle sostanze Ods, il fatto che i Cfc non dovessero essere regolamentati anche in base al loro Gwp.
In pratica l’assenza delle sostanze Ods da Kyoto e dell’effetto serra da Montreal ha prodotto una visione di due problemi separata che si è complicata a causa dell’utilizzo dei gas Hfc che sono stati utilizzati dal comparto della refrigerazione e della climatizzazione per sostituire buona parte degli Ods impiegati nel settore. Questo lo scenario al quale ci si è trovati di fronte verso la fine degli anni novanta e che le organizzazioni internazionali per la difesa dell’ambiente, come l’Unep, il braccio per la tutela ambientale delle Nazioni unite, hanno cominciato ad affrontare da alcuni anni. Il doppio beneficio di Montreal fu analizzato nel 1999 durante la Conferenza delle parti di Pechino, due anni dopo la firma dell’accordo di Kyoto che però è stato ratificato ed è entrato in vigore molto più tardi, nel 2005, e in quella sede si decise di accelerare, anche alla luce di questo nuovo scenario l’abbandono dei gas Cfc e Hcfc e di utilizzare gas alternativi con un basso potenziale Gwp; di rafforzare l’azione per la distruzione dei gas Ods contenuti nei vecchi impianti impedendo la possibilità di riciclaggio degli stessi per la revisione di sistemi che impiegano tali gas.
Problemi ancora irrisolti
Rimangono sul tappeto oggi due questioni. La prima è come concludere, magari accelerandola, la fase d’uscita dai Cfc, visto il doppio vantaggio che possiede l’abbandono di questi gas refrigeranti, senza però accelerare l’utilizzo degli Hcf che pur non danneggiando l’ozono hanno un alto fattore Gwp. Si tratta di una fase che è difficile normare visto che le alternative sul tappeto appartengono ancora al campo delle ipotesi tecnologiche e queste soluzioni necessitano di ricerca e sviluppo. L’Europa, per esempio, ha adottato una nuova direttiva la 2006/40/EC che fissa al 2011 il limite per l’utilizzo nei sistemi di condizionamento per autovettura di gas refrigeranti che abbiano un fattore Gwp maggiore di 150 nelle nuove autovetture, pena l’impossibilità di omologarle all’interno della Ue a 25 e fissa al 2017 il divieto di ricarica di qualsiasi impianto di condizionamento su automobili con tali gas refrigeranti.
La soluzione proposta dalla Commissione europea con la direttiva in questione riguarda la famiglia dei gas fluorurati che contribuiscono per circa il 5% all’effetto serra. Si tratta di 25 gas fluorurati, sottoposti al controllo del Protocollo di Kyoto: diciassette idrofluorocarburi (Hfc), sette perfluorocarburi (Pfc) e l’esafluoruro di zolfo (Sf6) un vero e proprio killer del clima che ha un Gwp pari 23.900 e una permanenza nell’atmosfera di circa 50.000 anni.
La Commissione stima che senza un regolamento restrittivo specifico le emissioni di gas fluorurati in atmosfera passerebbero dai 65 milioni di tonnellate equivalenti di anidride carbonica nel 1995, a ben 98 milioni nel 2010. Per fare fronte a questo problema le aziende costruttrici di autovetture stanno esplorando una serie di possibili soluzioni come l’utilizzo della CO2 e dell’Hfc 152a.
La CO2 contenuta in un sistema di condizionamento automobilistico, infatti, avrebbe un effetto praticamente nullo – visto che la carica all’interno di un sistema di condizionamento mobile è al massimo di un chilogrammo, pari a quanto emette di CO2 un’autovettura media durante un percorso di una decina di chilometri. Mentre l’utilizzo dell’Hfc 152a – Gwp pari a 140 -, in sostituzione del ben più pericoloso Hfc 134a – Gwp pari a 1.300 – avrebbe anche il vantaggio che il primo ha un tempo di degrado nell’atmosfera dieci volte più rapido del secondo: 1,4 anni contro quattordici.

In una recente discussione al Parlamento europeo – poco dopo l’allarme sul clima lanciato dall’Ipcc a gennaio 2007 durante la presentazione del nuovo rapporto a Parigi e la definizione degli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni climalteranti entro il 2020 – alcuni parlamentari europei avevano proposto di far scendere il livello di Gwp ammissibile fissato dalla direttiva 2006/40/EC da 150 a 50, ma la proposta a oggi non è passata.
Nel frattempo giganti della chimica del calibro di Dupont, Honeywell e Ineos Fluor hanno annunciato a più riprese di aver creato nuovi gas Hfc caratterizzati da un Gwp estremamente basso. Si tratta di una partita industriale difficile e complessa che le industrie hanno tutto l’interesse a vincere vista la crescita del mercato automobilistico in vista dell’ingresso sulla scena dei consumatori asiatici. Bisogna considerare però anche il fattore legato all’efficienza energetica. I nuovi gas refrigeranti, infatti, potrebbero essere caratterizzati da un fattore Gwp ancora alto – anche se naturalmente non altissimo – ma potrebbero consentire la realizzazione di sistemi di condizionamento e refrigerazione, sia mobili, sia fissi, contraddistinti da un basso consumo d’energia. In questo caso il calcolo dell’impatto sul clima dovrebbe passare da quello Gwp a quello Tewi che analizza il peso di un sistema sull’effetto serra analizzando tutti gli aspetti legati al funzionamento dell’impianto e utilizzando come approccio il ciclo di vita.
3 ottobre 2007



.jpg)


















.gif)