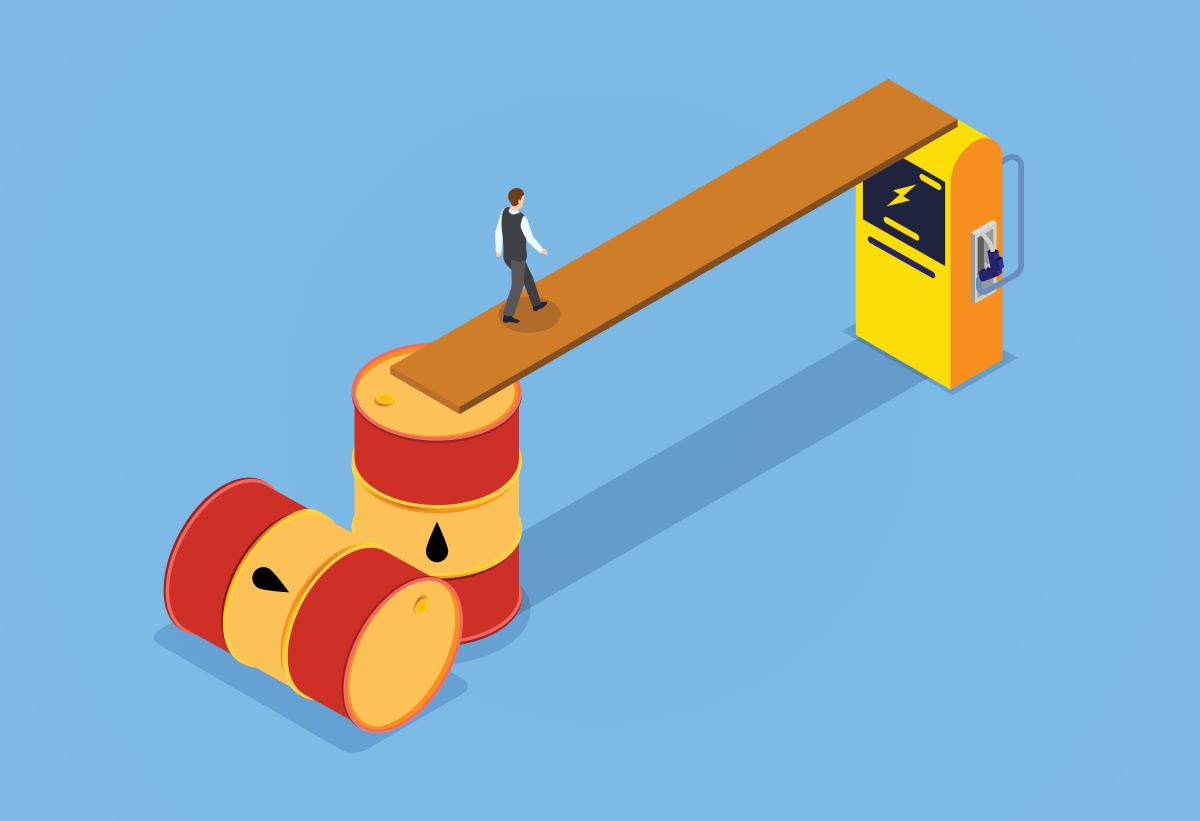Il tema dell’energia si svolge da decenni guidato da alcuni messaggi che evidenziano un aspetto molto evidente per il pubblico e che fanno da traino a tutto un bagaglio di dati, concetti, progetti e prospettive.
Se riesamino la mia esperienza personale si è passati dal messaggio di autarchia dell’anteguerra, alla povertà degli anni ‘40, all’espansione dei consumi degli anni ‘50 e ‘60, alla crisi dei rifornimenti degli anni ‘70, agli interventi dimostrativi degli anni ‘80, alle potenzialità delle rinnovabili degli anni ‘90, all’allarme sul clima globale degli anni 2000 e poi alla necessità di valutare la sostenibilità delle scelte nel decennio attuale.
Il messaggio di oggi presenta la necessità e le potenzialità di una “economia circolare” di tutte le risorse, compresa anche l’energia. Sono questi degli slogan facili da orecchiare, solo in parte capaci di riassumere e sintetizzare la complessità dei vincoli della natura e dei desideri delle persone.
Se ricordiamo però che in un sistema chiuso l’energia utilizzata non si distrugge, ma evolve in forme sempre meno utilizzabili, con l’entropia sempre crescente, ci si rende facilmente conto che è velleitario cercare di affrontare le nuove sfide avendo come strumenti quantitativi e qualitativi sempre e solo i vecchi corredi di dati e di interpretazioni dei fatti che usavamo quando l’economia e la società erano molto più parcellizzate in tante monadi indipendenti, quali erano i vecchi Stati nazionali.
L’individuazione e l’organizzazione di strumenti interpretativi adeguati a comprendere e governare la transizione è una operazione complessa e costosa ed è ostacolata dal tentativo delle strutture esistenti di partecipare all’evoluzione mantenendo ruoli e poteri.
A partire dal 2000 la UE ha programmato una serie di interventi per il controllo dei cambiamenti climatici basati sulla decarbonizzazione dell’energia attraverso tre principali direttive:
- la valorizzazione di fonti energetiche rinnovabili
- la penalizzazione dell’uso di combustibili fossili
- la riduzione della domanda di fonti energetiche attraverso il miglioramento dell’efficienza nel loro impiego.
Il primo tema ha prodotto impegni precisi con obblighi per ogni paese, ugualmente anche il terzo obiettivo ha prodotto impegni precisi anche se senza obblighi, accompagnati da meccanismi incentivanti, in Italia i TEE.
Il secondo tema fu affrontato all’inizio degli anni 2000, quando i consumi erano ancora in espansione, prima della crisi finanziaria della seconda metà del decennio; il meccanismo denominato “ETS”, Emissions Trading Scheme, prevedeva l’assegnazione iniziale di quote gratuite alle imprese grandi emettitrici, quote commerciabili per favorire interventi in impianti più obsoleti in paesi fuori UE.
Le quote si sarebbero ridotte progressivamente con previsione di penalizzare i superi con penalità di 30-40 €/ton di CO2. Questo meccanismo, più complesso di una Carbon Tax diretta, ha perso la sua efficacia per la forte crisi dei consumi e per il livello troppo alto delle quote, per cui il valore commerciale della CO2 naviga da anni attorno ai 4-5 €/ton, livello del tutto insufficiente a produrre effetti sulle scelte delle imprese.
Gli effetti della mancanza di una carbon tax efficace non sono importanti solo a livello di analisi strategica ma hanno una ricaduta diretta sulle tariffe pagate dai consumatori dei vari paesi UE.
In Italia in particolare nel decennio 2004-2014 la generazione elettrica dalle “nuove” fonti rinnovabili, solare eolico e biomasse, è aumentata di circa 50 TWh, grazie agli incentivi a carico dei consumatori (dai circa 12 c€/kWh dei certificati verdi ai circa 30 c€/kWh del conto energia).
Questa nuova produzione ha sostituito quasi tutta la generazione da prodotti petroliferi e parte della generazione da metano, mentre ha penalizzato solo marginalmente sia la generazione da carbone, sia le importazioni dall’estero.
Infatti la generazione da carbone presentava, nel periodo, costi minori di qualche c€/kWh rispetto ai 5-6 c€ del prezzo di Borsa, così come i 45-50 TWh importati, prima delle chiusure di centrali francesi a fine 2016, da Francia (nucleare) e da Germania (lignite e carbone), godevano di un margine dello stesso ordine indicato dalle differenze di prezzi fra il mercato italiano e quelli di questi paesi.
Come risultato globale si sono ridotte le emissioni di CO2 di circa 40 Mton, mentre sostituendo la generazione a carbone, almeno negli impianti meno recenti e meno efficienti, le emissioni sarebbero state ridotte di ulteriori 19 Mton, quasi il 50% di più.
I consumatori civili e industriali hanno accettato di pagare costi, dell’ordine dei 12 miliardi/anno di € per l’impiego delle rinnovabili, mentre le imprese dell’industria dell’elettricità, in assenza di una tassazione efficace delle emissioni, hanno scelto di far funzionare gli impianti esistenti con i più bassi rendimenti anche se con le emissioni specifiche più elevate, marginalizzando così l’efficacia dell’impegno economico dei consumatori.
Riconsiderando tutta la questione a distanza di un po’ di anni si può valutare che i consumatori hanno accettato di ridurre i loro consumi (sia per convinzione, sia grazie all’innovazione, sia infine per impossibilità di reagire), mentre le imprese, specie quelle energy intensive avevano la possibilità o di accettare le penalizzazioni riducendo la loro forza sul mercato mondiale, o reagire delocalizzandosi in altri paesi o infine chiudendo le attività.
Questi temi non erano apertamente considerati nelle scelte della UE, pensando che fosse possibile condurre una funzione di leadership e di esempio per tutti gli altri paesi; le reazioni sono state lasciate agli stati membri.
La Germania ha da subito separato il peso per i consumatori da quello per le imprese, promuovendo le rinnovabili, ma mantenendo lignite e carbone. L’Italia si è accorta del problema solo quando si è manifestata in tutta la sua gravità la crisi della nostra manifattura, con reazioni per ora limitate.
Un altro esempio della inadeguatezza degli strumenti attualmente esistenti per gestire la transizione, è quello dei bilanci energetici nazionali, quali il nostro B.E.N. con le sue convenzioni legate al contesto prevalentemente industriale degli anni ‘60, o quello Eurostat con le sue maggiori attenzione alle fonti rinnovabili termiche, al calore recuperato e al settore degli impieghi domestici.
Questi bilanci nazionali mettono in ingresso sia le fonti fossili estratte nel paese o importate, sia quella parte di fonti rinnovabili interne utilizzate, valutandole sulla base dei vettori energetici generati.
L’insieme delle fonti fossili e dei vettori energetici ottenuti dalle rinnovabili viene trasferito al settore dell’industria dell’energia; queste imprese gestiscono le trasformazioni nei vari vettori che distribuiscono agli utilizzatori finali, principalmente elettricità, metano, carburanti per il trasporto. Gli utilizzatori finali poi impiegano i vari vettori sia per servizi (quali il trasporto di persone e merci, il riscaldamento e l’illuminazione degli ambienti e anche la cura delle persone e l’intrattenimento culturale e del tempo libero), sia per la produzione di beni e infrastrutture.
Questo schema rappresentava abbastanza bene la situazione nel primo dopoguerra, invece nella società globalizzata e in forte evoluzione organizzativa, attenta al clima globale e alla sostenibilità nell’uso delle risorse, si presenta fortemente inadeguato.
Una carenza globale è costituita dalla mancata presa in conto, né dell’energia inglobata nei prodotti e nei servizi che sono importati, né di quella inglobata nei prodotti e servizi esportati. L’Italia è un paese quasi privo di materie prime quindi forzatamente trasformatore non solo per le produzioni meccaniche e chimiche, ma anche nel settore alimentare materie prime che importa e che rivende trasformate in prodotti a maggior valore aggiunto.
Le attività industriali nel 1982 assorbivano il 38% dei consumi finali italiani, allora pari a 94,6 Mtep, nel 2015 esse si erano ridotte al 22% dei consumi finali saliti a 116 Mtep: c’è stato un spostamento dei consumi dall’industria ai servizi e ai trasporti, non tanto per il ben noto invecchiamento della popolazione, ma soprattutto per la delocalizzazione e/o chiusura di molte attività produttive labour intensive e energy intensive e a maggior ragione, aumento delle importazioni di prodotti e semilavorati con energia inglobata quali le automobili.
Nello stesso periodo si sono ridotte le nostre esportazioni di prodotti con contenuto di metalli quali gli elettrodomestici bianchi, sostituite da esportazioni di prodotti quali moda e vini, a contenuto energetico molto più ridotto.
Volendo quindi valutare il contributo italiano al consumo delle risorse, alla evoluzione del clima ed alla produzione di inquinanti a larga diffusione si dovrebbe tener conto anche delle lavorazioni fatte, al nostro servizio, in altri paesi. Quando queste lavorazioni avvengono in paesi con normativa, ambientale e di protezione dei lavoratori, meno stringente nasce anche un fenomeno di dumping ambientale e sociale che danneggia le nostre imprese.
La scelta della UE di assumere una posizione di leader nel settore delle normative ambientali, finisce per danneggiare sia l’ambiente del globo sia le imprese europee meno in grado di spostarsi su produzioni a maggiore valore aggiunto.
Appare necessario rivedere il meccanismo ETS, penalizzando anche l’energia inglobata nei prodotti importati, tema molto complesso e interconnesso con le mille facce della globalizzazione; indubbiamente questa ha fatto uscire uno-due miliardi di asiatici dal sottosviluppo ma alla fine non sarà un pranzo gratuito. La UE non ha ancora affrontato la questione che rischia di incancrenire nelle polemiche del populismo anti-unione e degli Stati sempre meno sovrani.
Un’altra inadeguatezza deriva dall’interesse all’economia circolare. Gli schemi di bilancio energetico in atto conteggiano, a consuntivo, l’energia prelevata dalle risorse e trasferita ai consumi. L’attenzione alla conservazione delle risorse con lo sviluppo di una economia circolare porta a predisporre una possibilità di riconsiderare, come regola base, la modifica dei comportamenti, il riuso dei prodotti, il riciclo dei materiali, la valorizzazione energetica dei materiali a fine vita, con una serie di rimessa in circolo, dagli usi finali verso le risorse primarie.
In alcuni casi più semplici, ad esempio per i “CSS”, i combustibili solidi secondari, prodotti dalle imprese di gestione dei rifiuti, è possibile usare lo schema tradizionale dei bilanci energetici, riportandoli in ingresso al paese, come una fonte primaria denominata “rifiuti non rinnovabili”; in molte altre situazioni il ricircolo avviene all’interno degli usi finali, riutilizzando i prodotti e le materie, oltre all’energia in esse inglobata, in modi difficilmente formalizzabili e documentabili, a seconda della qualità e regolarità del recupero.
L’Italia aveva una lunga tradizione di economia circolare con riuso delle materie prime in molti settori produttivi, tradizione in parte mantenuta. Le nostre imprese siderurgiche nel 2014, hanno prodotto 23,7 Mton di acciaio rifondendo circa 18 Mton di rottami e prodotti a fine vita.
La produzione della carta è partita dal riciclaggio degli stracci di cotone, recupero oggi basato sulle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, delle 9 Mton di carta prodotte nel 2012 ben 5,2 Mton originavano dal macero; nel vetro 2 Mton di involucri in vetro cavo hanno utilizzato 1,4 Mton di rottame; è invece scomparso il riciclaggio della lana dai vestiti usati, la “lana meccanica di Prato”.
Queste quantità di energia non consumate, non sono prese in considerazione dai bilanci energetici redatti nei modi tradizionali, nonostante la UE abbia preso impegni non solo sulla valorizzazione di nuove fonti rinnovabili di energia, quantità generalmente ben misurabili, ma anche sulla riduzione dei consumi e sull’aumento dell’efficienza, parametri spesso meno definibili e fortemente interconnessi con il riciclo delle materie e il riuso dei prodotti.
Invece abbiamo avuto molte difficoltà nell’affrontare nuove filiere di riciclo, per continui conflitti con le normative e le paure legate all’inquinamento. A partire dall’incidente di Seveso nel 1976 la produzione legislativa e l’attenzione delle popolazioni si è focalizzata sulla formalizzazione del concetto di rifiuto e la definizione delle relative responsabilità, finendo così il privilegiare la formalizzazione dello smaltimento come destinazione finale, rispetto al riuso o alla valorizzazione energetica. La complessità delle regole e della documentazione richiesta, insieme alla carenza di controlli non formali, finiscono per costituire quasi un alibi alle attività della criminalità organizzata, ben capace di muoversi in questo ginepraio.
Abbiamo così una nuova “linea gotica” al nord della quale la quota non riciclabile di rifiuti urbani è valorizzata energeticamente per elettricità e teleriscaldamento, mentre a sud di questa linea una quota rilevante dei rifiuti urbani è spedita in inceneritori nordeuropei o in discariche di paesi meno fortunati o meno attenti, con spreco evidente di risorse e di potenziale occupazione qualificata. La situazione del trattamento dei reflui solidi e liquidi degli allevamenti animali non è molto diversa; impianti per biogas da una parte, spandimenti non sempre oculati dall’altra.
Le attività manifatturiere italiane, caratterizzate da una larghissima presenza di PMI, con forte specializzazione produttiva in piccole unità disperse nel territorio, richiedono che gli scarti e i residui delle attività principali escano dal recinto dell’azienda per entrare in quello di un’altra azienda; in questo passaggio sul suolo pubblico si formalizza il carattere di rifiuto, sia pure non pericoloso, con tutto il suo carico di vincoli e di norme anche penali. Ben diversa è la situazione dei grandi complessi industriali nordeuropei dove tutte le lavorazioni e le trasformazioni avvengono all’interno della recinzione senza nessun formalizzazione di rifiuto.
Solo alla fine del 2016 è stato emesso dal MATT il decreto sulle materie seconde, atteso da anni. Il decreto individua una moltitudine di flussi di materiali, specie nelle aziende agricole e nelle aziende del settore alimentare, indicando come si può formalizzare il loro stato di materie seconde, il loro trasporto e il loro utilizzo.
Basti citare due esempi. Ci sono ogni anno milioni di tonnellate di rami e ramaglie, derivate dalle potature dei viali alberati nelle città, che non dovranno più essere inviate, pagando i costi dello smaltimento, agli impianti di compostaggio, ma potranno essere vendute alle aziende di teleriscaldamento. Ugualmente il sangue raccolto nei mattatoi non dovrà più essere inviato allo smaltimento per la trasformazione in farine animali da usare poi come CSS, potrà essere direttamente venduto a digestori dei reflui degli allevamenti per la produzione di biogas.