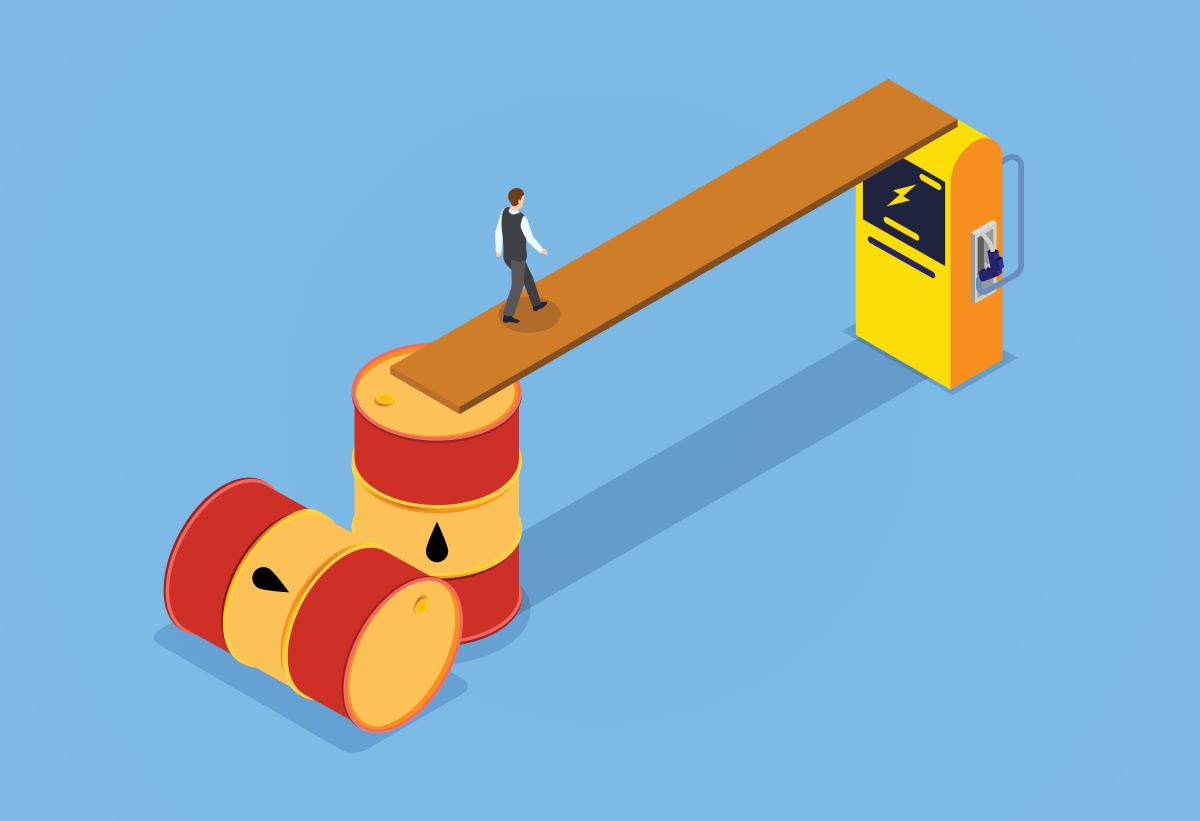Nei giorni scorsi è arrivato un dato importante dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA): l’UE è in traiettoria per raggiungere e superare il target al 2020 sulle emissioni, anche se per quelli al 2030 e al 2050 sarà necessario un cambiamento radicale delle modalità di produzione e utilizzo dell’energia.
Dalla relazione “Trends and projections in Europe 2015” (allegato in basso) emerge infatti che le emissioni di gas-serra sono diminuite del 23% nel periodo 1990-2014 e si apprestano a raggiungere al 2020 quota -24% che diventa -25% con le misure aggiuntive previste dai Stati membri.
“Si tratta di un segnale forte in vista della conferenza di Parigi sul clima a riprova del fatto che l’Europa rispetta i propri impegni e che le nostre politiche in materia di energia e clima stanno dando i loro frutti”, ha commentato il commissario Ue all’Energia e al Clima, Miguel Arias Cañete.
Un dato falsato?
Dati e affermazioni che però andrebbero messi in prospettiva: l’Europa ha buone prestazioni in termini di emissioni anche perché in gran parte le “delocalizza”. Ad esempio, ieri abbiamo pubblicato i dati MiSE su come si sono ridotti i consumi di energia in Italia e di come è migliorata l’intensità energetica, cioè il rapporto tra Pil e fabbisogno energetico, che nel nostro Paese è sceso di quasi 9 punti percentuali dal 2010 al 2014. Se l’efficienza energetica ha i suoi meriti in questi risultati, ha un notevole ruolo anche il cambiamento strutturale della nostra economia, che negli ultimi decenni ha visto parte della produzione industriale spostarsi all’estero, spesso nei Paesi emergenti.
Insomma, quel calo del 23% delle emissioni europee certificato nel nuovo report EEA andrebbe confrontato con l’andamento delle importazioni, per quantificare la CO2 che è dovuta ai nostri consumi, anche quando l’anidride carbonica causata dai prodotti che compriamo finisce in atmosfera nei Paesi da cui li importiamo.
Emissioni “consumate” nei paesi ricchi, ma prodotte soprattutto in quelli emergenti con un’economia basata sull’export, come la Cina: un quarto delle sue emissioni viene dalla produzione di merci destinate all’estero. Secondo uno studio di qualche anno fa della Carnegie Institution for Science oltre un terzo delle emissioni legate al consumo di beni e servizi nei paesi ricchi avviene al di fuori dei loro confini. Alcune nazioni come la Svizzera “delocalizzano” più della metà della CO2. Un “outsourcing” di dimensioni tali da non poter essere ignorato quando si pensa alla strategia mondiale per rallentare il global warming.
Come cambierebbero i conti
Dati che andrebbero aggiunti a complemento di quelli sulle emissioni procapite considerati normalmente: calcolando anche la CO2 emessa all’estero per i beni consumati in patria, ad esempio, le emissioni di ogni italiano sarebbero di circa un quarto più alte.
Altro studio che fa questi conti (del 2011, allegato in basso) viene dall’ong Carbon Trust e da lì è preso il grafico qui sotto (dati riferiti al 2004): come si vede circa un quarto delle emissioni mondiali vengono “scambiate” e contabilizzando la CO2 incorporata nei prodotti importati nazioni ricche come il Regno Unito la vedrebbero salire del 34%.
La catena delle emissioni
Per capire la catena mondiale della CO2 bisogna però guardare la questione anche da un altro versante: la provenienza dei combustibili fossili dai quali hanno origine le emissioni. Sempre la Carnegie Institution, assieme al Centro per la ricerca climatica e ambientale internazionale di Oslo, in un altro studio lo ha fatto, disegnando mappe delle emissioni che descrivono e integrano i tre aspetti: in quali paesi i combustibili fossili vengono estratti, dove vanno e dove vengono bruciati, dove vengono consumati i beni e i servizi ottenuti con quell’energia.
L’interdipendenza mondiale in fatto di energia ed emissioni ne esce dipinta con tratti più chiari e rende ancora più evidente come un accordo sul clima non possa essere efficace se non coinvolge in qualche modo tutti. Se da una parte, infatti, nazioni importatrici come quelle europee sono responsabili di parte delle emissioni dei paesi da cui acquistano i beni consumati, come Cina e India, dall’altra è chiaro che questi ultimi beneficiano economicamente di tali scambi e che lo stesso fanno i paesi che esportano petrolio, gas e carbone, che sono all’origine di tutta la catena.
La soluzione carbon tax
La ricetta per affrontare il problema? Secondo molti è spostare lungo la catena della CO2 la regolamentazione delle emissioni, andandole a colpire alla radice. Cioè, introducendo una carbon tax. “La concentrazione geografica dei combustibili fossili e il numero relativamente ristretto di operatori, suggerisce che mettere le restrizioni già al pozzo, fuori dalla miniera o dalla raffineria minimizzerebbe sia i costi di transazione che le possibilità di fughe dal meccanismo”, commentavano dalla Carnegie Institution presentando il report citato.
Una bandiera, quella della carbon tax, che è stata presa in mano da istituzioni e leader importanti: in vista della prossima Cop 21 di Parigi è nato il Carbon Pricing Panel, un’alleanza trasversale indetta dai numeri uno della Banca Mondiale, Jim Yong Kim, e del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, e che vede tra gli aderenti la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese François Hollande e diversi altri leader mondiali.